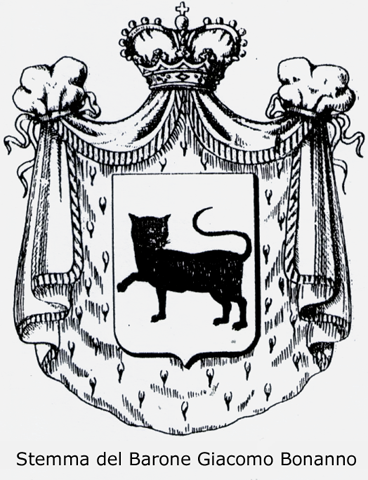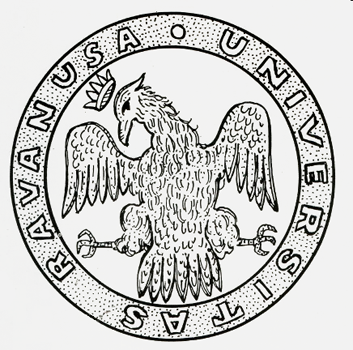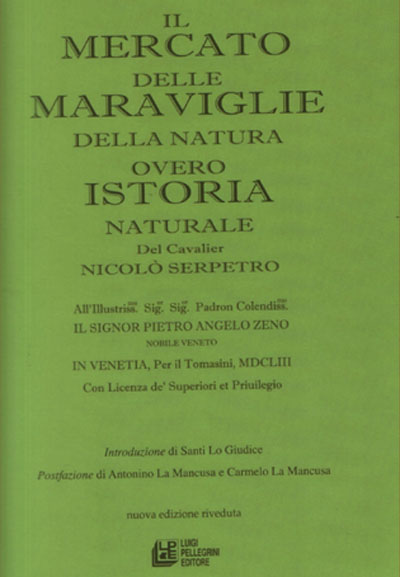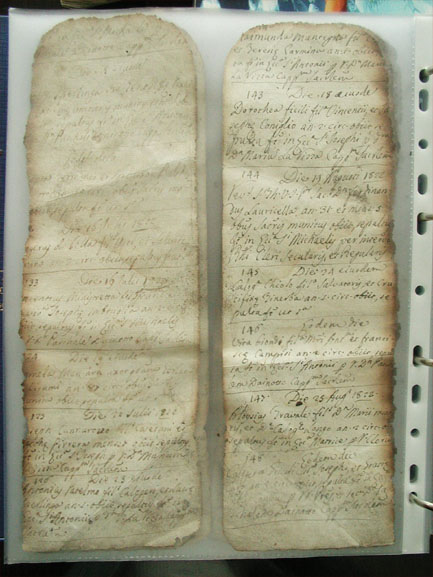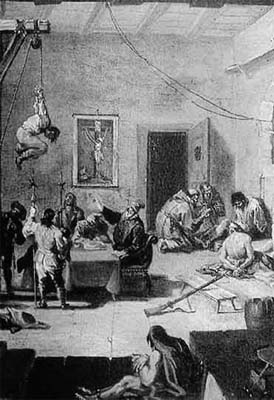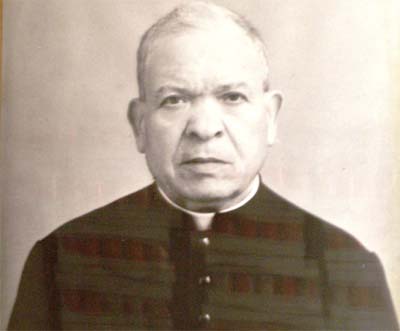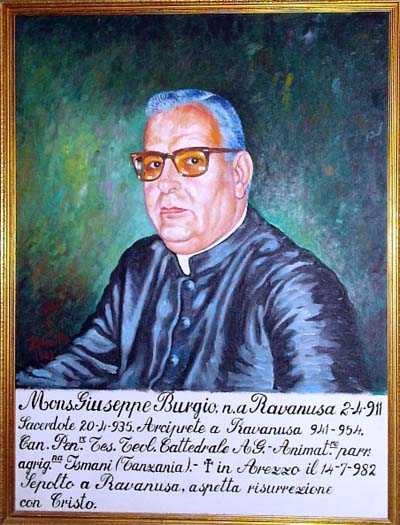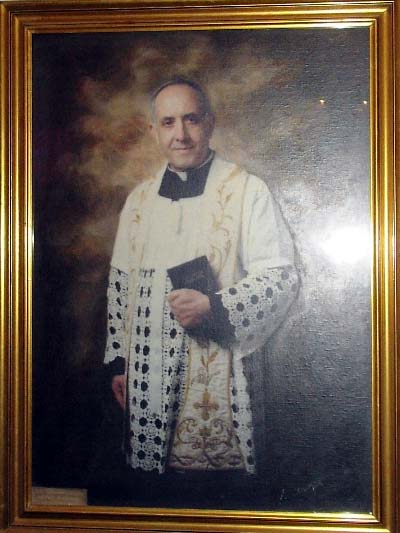|
Salvatore Aronica, ha conseguito: Laurea in Pedagogia con il massimo dei voti e tesi sul Federalismo europeo, Relatore il chiar.mo prof, Giorgio Spini – Abilitazione in Storia e Filosofia nei Licei – Diploma di Studi Superiori Europei, con tesi su Toynbee, Relatore il prof. Pierre Grappin della Sorbona, presso il Centro Europeo Universitario di Nancy (Francia). Dal 1952 ha insegnato nei tre ordini di scuola. Ha preso parte, inoltre a molti corsi a Roma del MFE diretti da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi e a diversi stages in Francia diretti da A. Marc del CIFE (Centro Internazionale di Formazione Europea) di Parigi. Nel luglio 1958 ha partecipato ad un’ampia inchiesta sociologica sull’adattamento della manodopera italiana nel Bacino Carbonifero di Lorena a cura della Direzione Generale di detto Bacino con sede a Merlebach. Nel 1965 ha fondato e diretto “Il Saraceno – mensile di attualità sociali ed economiche”. Nel 1966 è stato consigliere 1° eletto nelle liste della DC, a Ravanusa ed Assessore comunale. Dal 1966 al 1994 vincitore del concorso per esami e titoli è stato immesso nei ruoli dei direttori didattici. Ha lasciato la scuola dopo un quarantennio di servizio con Diploma di benemerenza di 1^ classe - medaglia d’oro - del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro P.I. Ha pubblicato: Filosofia della Storia d’Arnold J.Toynbee (Lugano 1961) – Un mignolo di Sud (Parma 1963), ottenendo il 2° Premio Nazionale di poesia “Città di Gela”. – Sulla rivista “Cenobio” di Lugano i seguenti saggi, editi pure per estratto: – Junius: Scritti federalisti sotto pseudonimo e clandestini di Luigi Einaudi - - Il Gruppo di Ventotene, ossia le origini clandestine del Movimento Federalista Europeo – La civilisation occidentale et ses problemes chez A. J. Toynbee - - L’esperimento della Scuola Europea di Lussemburgo - – L’idea europea tra le due guerre -. Su “Galleria”, rassegna bimestrale di cultura, diretta da L. Sciascia – “La Voce Repubblicana”, quotidiano – “Il Pensiero Mazziniano”, mensile – “La Vedetta”, mensile - “Europubblik”, mensile – “Lu Papanzicu”, mensile – un centinaio di articoli di storia, archeologia e canti popolari siciliani Ha collaborato, infine, alla “Guida alla Sicilia jacopea (Edizioni Compostellane, Pomigliano d’Arco, 2004), per la voce “Ravanusa”. 1 - LE BARONIE A RAVANUSA (1080 - 1448)1080-86 Hamûd (Camut), Signore musulmano di Agrigento e di tutto il territorio circonvicino sino a Castrogiovanni. Convertitosi al cristianesimo finisce esule con i suoi tesori a Mileto in Calabria. 1086 Il Conte Ruggero il Normanno, dopo la resa di Agrigento del 25 luglio, conquista undici castelli, tra cui Caltanissetta, Bifara, Licata e “Remisse” e ne diviene Signore. Ne abbiamo notizia dal Malaterra, cronista ufficiale al suo seguito. Remisse viene identificato concordemente dagli antichi storici con “Ravanusa”.
1089 Salvatore Palmieri, anch’egli normanno, viene nominato primo barone di Ravanusa e di Canicattì dal cugino Conte Ruggero, consegnandogli la propria preziosa ed istoriata spada (custodita poi con le armi sottratte ai Saraceni di Ravanusa nel Castello di Canicattì), per aver contribuito alle sue vittorie con un drappello di 80 cavalieri e per aver vinto in duello l’emiro Melciabile Mulè. 1130 Tutto il nostro territorio, a nord-ovest di Butera, oltre il Salso, e a sud del casale ebraico La Iudeca, fu appresso donato da Enrico Aleramico al monastero di San Bartolomeo di Lipari per essere abitato e coltivato. 1154-71 Padrone del territorio tra Girgenti, Naro e Licata divenne, quindi, Abdisaleno, figlio di Abdisaliabar. Da costui lo comprò il vescovo Gentile. Da documenti della Curia di Girgenti risulta ch’egli dai Saraceni acquistò molti casali della sua diocesi. Il nome di questo ricco Saraceno deriverebbe da “Salem”, “pace”. Così era chiamata, dal clan indigeno dei Gebusei l’arcaica Gerusalemme. 1177 La chiesa “S. Maria de Ravenosa” è menzionata in un “Elenco di censi” della chiesa agrigentina. La predetta Chiesa e il casale, perché scarsamente abitato, non figurano tra i 150 luoghi abitati, rilevati dalle Collette del periodo angioino. Comunque appartengono al vescovo di Agrigento. 1308-10 Un presbitero, tale Biagio, paga le decime per sé e per la chiesa “S. Maria de Rave= nusa”. 1333 Il vescovo di Agrigento Filippo Ubaldi, non potendo ricavare le decime dai pochi abitatori del casale di Ravanusa, lo vende a Goffredo Curatore di Messina, che è l’arrendatario (esattore con appalto) dei beni della chiesa agrigentina. 1336 Nicolò Tagliavia, figlio o nipote di Bartolomeo T. di Girgenti. 1360 Giovanni Tagliavia, cavaliere agrigentino, figlio di Nicolò. Possiede il “Castello e la Terra” di Ravanusa, che gli vengono tolti per una “certa disubedienza regia”. 1371 Il castello e la terra di Ravanusa da Re Federico III sono dati in concessione a Pietro Di Mauro, cavaliere messinese. Il quale li cambiò con un altro feudo. 1374 Feudo e casale di Ravanusa pervengono a Fulco Palmeri di Naro. Questi compra i feudi vicini Bosco, Cugno di Dama, Milici, Furiana e Spatafora da altri proprietari. Per fellonia perde feudo e casale di Ravanusa. 1392 Li ottiene Luigi Tagliavia, di Agrigento, nipote di Giovanni Tagliavia, per intervento di Nino Tagliavia, che aveva reso omaggio feudale in Spagna ai nuovi sovrani Maria e Martino. Gli vengono, però, presto tolti dallo stesso re Martino, per fellonia. 1393 Mutio Landolina, cavaliere di Noto, per concessione di Re Martino. Poco dopo, cambiò i possedimenti di Ravanusa per il castello di Noto, con Rodrigo Zappada, allora castellano di detto castello. 1402 Rodrigo Zappada, il 13 giugno. 1408 Da tempo imprecisato, Salvatore Fulco Palmerio è potente e temuto barone del feudo e casale di Ravanusa. Il suddetto subentra anche nel feudo e castello di Canicattì, a Luca Formoso, cavaliere agrigentino. Dal registro feudale delle tassazioni, o “Ruolo”, di Re Martino del 1408, si rileva che il castello di Canicattì, posseduto da Salvatore Palmerio, viene aggregato alla città demaniale di Naro. Il casale di Ravanusa, proprietà degli eredi di Andrea Tagliavia (Pietro Tagliavia, poi suo figlio Andrea Tagliavia e, infine, Salvatore Tagliavia), invece, alla città di Licata, assieme a Bifara, Campobello (di Sancio De Xea), Favarotta e al castello di Palma Montechiaro (8). Casale e feudo di Ravanusa, per lo scarso numero di nuclei di popolazione, parimenti a molti altri luoghi poco abitati, non figurano nei “Ruoli”, o collette (subvenciones), del re Alfonso del 1434-43. I centri abitati allora, in Sicilia, erano 180, per come concordano Garufi e Cosentino. I predetti Ruoli imponevano un focatico in ragione di tre tarì a famiglia, escludendo dalla tassazione, a decorrere dal medesimo anno 1434, gli ecclesiastici. Anche per questo, non riportano i nomi dei presbiteri titolari della chiesa S. Maria di Ravanusa. 1448 A Salvatore Fulco Palmeri succede il figlio Antonio Palmeri, “milite” (grado iniziale dell’aristocrazia nobiliare). Rimasto senza prole, il 12 novembre, con atto del notaio Piazza di Girgenti, vende il feudo di Canicattì per 250 oz. al nipote Andrea De Crescenzo, che lo tiene sino al 1485. 1449 Andrea De Crescenzo, appartiene a una famiglia nobile di Piacenza, trasferitasi da tempo a Girgenti. Sposa la figlia di Filippo Palmeri, sorella di Antonio Palmeri, e recupera il feudo di Ravanusa, accordandosi con Zappada. 1451 Andrea De Crescenzo ottiene dal re Alfonso d’Aragona, con privilegio emanato in Torre Ottavio il 20 Gennaio XV Ind. 1451, di costruire nel feudo di Ravanusa un ospizio o fondaco, con l’esenzione della gabella del vino e della dogana su tutte le merci pervenute e vendute in detto ospizio, per sé e per i suoi eredi. Nei pressi ha già eretto un convento, che affida, nel 1452, ai Canonici di S. Giorgio in Alga. 1467 A. De Crescenzo il 3 febbraio ottiene dal re Giovanni d’Aragona la “licentia populandi” e il “Mero e Misto imperio” nel feudo di Ravanusa”, ma non avvia alcuna altra costruzione. Del resto su una diecina di licentiae populandi, ottenute da signorotti e baroni nel 1400, soltanto in Castel di Lucio e a Canicattì realizzarono subito le case per i nuovi abitatori. In tutti gli altri luoghi (ad es. a Riesi), rinviarono l’uso della licentia, anche per oltre oltre un secolo. 1472 Il De Crescenzo ottiene che il feudo di Ravanusa, da “piano”, diventi “nobile”, ossia popolato. Ciò viene concesso solo a quei feudi, sedi nel passato di un casale, o almeno di un castello. E Ravanusa, sin dal trecento ebbe casale e castellania. Per il 1472, il casale di Ravanusa dichiara una rendita di 80 oz. annue. 1503 Giovanni De Crescenzo lo vende a Giovanni De Grimaldo, che ne è investito il 10.2.1503. 1507 Giovanni Andrea De Crescenzo lo ricompra e ne ottiene l’investitura l’8.5.1507. L’eredita Giovanni De Crescenzo di Andrea. Questi non ha figli maschi e lascia il feudo di Canicattì al genero calatino Francesco Calogero Bonanno, barone di Rafforosso, che aveva sposata in seconde nozze la figlia Ramondetta (dopo la morte della prima moglie Agata Gravina, figlia del barone di Belmonte). Francesco Calogero B. diviene il capostipite, a Canicattì e a Ravanusa, della plurisecolare baronia dei Bonanno.Assai ricco e di chiara fama, fu ambasciatore per l’università di Caltagirone di Re Ferdinando il Cattolico, in Napoli. Da cui fu ornato del cingolo militare con titolo di cavaliere dello sprone d’oro. Morì giovane. Ramondetta sposò a seconde nozze il nobile Angelo Lucchesi di Naro, malfamato, come il padre, che fu odiato secreto ed esattore di detta città demaniale. 1530-52 Geronimo Bonanno, fratello di Francesco Calogero. Sposa Biandra, seconda figlia di G. De Crescenzo e così diviene barone di Ravanusa. Non avendo prole, alla sua morte l’eredità ritorna a Ramondetta. 1553 Ramondetta De Crescenzo e il figlio Filippo, avuto dal primo marito Francesco Calogero Bonanno, raggiunta la maggiore età. 1554 Filippo Bonanno e De Crescenzo. Sceglie a dimora il castello di Canicattì, ove cura soprattutto l’armeria, famosa per il trofeo d’armi dei vinti Saraceni trasferitovi sin dall’epoca normanna. Dopo la morte della madre Ramondetta, ottiene l’investitura, il 2.6.1554. Sposa Eleonora Platamone, figlia di Pietro P. cavaliere siracusano. Filippo B. fu cavaliere assai spiritoso e di allegre brigate. Non ci furono giochi o feste nel Regno di Sicilia a cui non intervenisse. Ebbe aspre e criminali contese col patrigno “naritano” Angelo Lucchese e ferocia nel vendicare gli oltraggi subiti. Prodigo, andò ambasciatore per Caltagirone da Carlo V e mantenne a sue spese 200 soldati di fanteria per tre mesi. 1555 G.Battista Bonanno e Platamone. Sposa Isabella La Rocca, da cui nascono Filippo, Pietro, Leonora e Maria. Ottiene l’investitura il 18.1.1557. Preferisce abitare a Siracusa, ove esplica la funzione di maestro-segretario della Regia Camera. Nomina governatore Antonio Palmieri e gli affida la terra di Canicattì e il feudo e casale di Ravanusa. Siede al 17° posto in Parlamento, con l’obbligo di disporre per il sovrano di tre cavalieri e diciassette fanti. Dopo la morte di Isabella (1581), sposa Giovanna Gioeni vedova di Fabrizio Romano barone di Montalbano, ottenendo altri figli (Giuseppe, Lucio e Orazio).E’ Capitano d’armi in varie città del Regno e partecipa all’impresa della Goletta. Muore a Siracusa nel 1597. 1597 Filippo Bonanno e La Rocca. Ottiene l’investitura del feudo e casale di Ravanusa il 16.10.1613, dopo la morte del padre G.Battista B., avvenuta a Siracusa. Sposa Antonia Romano Colonna, duchessa di Montalbano (ME), con cui procrea 10 figli: Francesco, Fabrizio, Giacomo, Giovanni, Lutio, Isabella, Ramondetta, Lucia, Maria e Beatrice. In seconde nozze sposa donna Emilia del Carretto che non gli diede figli. Abita a Siracusa, ove ricopre prestigiosi incarichi nei principali uffici. E’ il primo duca di Montalbano. 3 - LE BARONIE A RAVANUSA (1619 – 1711) 1619 Giacomo Bonanno e Colonna. Sposa Antonia Balsamo, marchesa di Limina e Roccafiorita (ME), ottenendo dal padre, propter nuptias, l’investitura del feudo e casale di Ravanusa l’8.6.1619. Da donna Antonia ha i seguenti figli: Filippo, Pietro, Vittorio, Gerardo, Maria, Francesca, Lucrezia e Camilla. Compra dalla Real Casa per 6.000 oz. il mero e misto imperio (esercizio nel proprio feudo della giustizia civile e penale, che rendeva i baroni arbitri della vita e della morte dei loro vassalli), con la facoltà di popolare e di imporre tasse. Provvede alla costruzione, già avviata dal padre Filippo, di 80 case, assegnandole dietro pagamento, pure dilazionato, ai nuovi abitatori. Per invogliarli a risiedere nella “terra” di Ravanusa, concede loro prestiti in denaro, in frumento e soccorsi di masseria. Nel corso di un’assemblea con i vassalli, nella chiesa di S. Maria (Convento), il 24.8.1621 costituisce l’Universitas Ravanusa, il nostro Comune, concordando con i primi 35 capifamiglia che vi abitavano, l’imposizione delle proprie gabelle. Costruisce a totali spese proprie la Chiesa Madre, dedicandola a S. Giacomo. Altresì la chiesa di S. Giuseppe, edificata prima del 1623. Ottiene il diritto di Patronato nella Matrice, destinando al culto una rendita annuale di 40 oz.. Nomina il primo arciprete nella persona di Don Antonio Nicosia, proveniente da Mirto (ME), baronia dei Bonanno. Adotta a Ravanusa un pregevole piano regolatore con ampie e dritte strade, che ancora perdura, prevedendo altresì fontane e i “Comuni” (nei pressi del quartiere S. Michele) per la futura espansione urbanistica (tradita ai nostri giorni, da qualche amministratore della categoria “Cicero pro domo sua”), per il pascolo, gli erbaggi, la raccolta di legna, pietra e per lo smaltimento dei rifiuti solidi (i noti “munnizzara”). Don Giacomo è il più colto dei nostri baroni. Amico di letterati, viaggia molto in Italia, intessendo amicizie con i Colonna e con il cardinale Pier Paolo Crescenzio. Pubblica, nel 1624 a Messina, l’Antica Siracusa Illustrata (storia della sua città natale), in due volumi, ristampata dal pronipote Francesco Bonanno nel 1717 con un nuovo titolo Delle Antiche Siracuse. L’opera, oggi introvabile, merita un’ulteriore ristampa, anche per sancire un gemellaggio Siracusa-Ravanusa. Siracusa detiene, peraltro, nel santuario “Madonna delle Lacrime” le spoglie mortali del nostro concittadino arcivescovo Calogero Lauricella. Benefattore di Canicattì e Ravanusa, è ancora ricordato come munifico barone d’un periodo aureo: “a li beddri tiempi di lu baruni Japicu”. E per le grandiose fontane, le strade alberate, l’ospedale dei poveri e il lascito di cinque mila once agli abitatori di Canicattì. Per real privilegio è nominato duca il 31.8.1623. Sposa in seconde nozze la duchessa Innocenza Marchisia di Catania. Senza altra prole. Dei figli, tre (Gerardo da infante, Vittorio e Filippo adulti) gli premuoiono. Pietro diviene suo erede. Per poco. Delle sue figlie, Maria sposa il marchese Montaperto e le altre tre si consacrano suore benedettine di clausura nel monastero S. Salvatore a Naro e poi in quello della Badia a Canicattì. E’ sepolto, per disposizione testamentaria, nudo, in un’unica bara assieme alle spoglie mortali delle due mogli, nella chiesa S.Spirito di Canicattì. Ma i suoi resti con quelli delle mogli, a seguito di restauri nella chiesa, finiscono come le altre sepolture, nell’ossario del cimitero comunale. Nessuno mai si è presa la briga di ricordarlo, anche con una piccola lapide, pur avendo contribuito (lui e la moglie Marchisia) alla costruzione della predetta chiesa e dell’annesso convento. Vistose lapidi sulla parete destra della chiesa ricordano, invece la munificenza di altro barone, Bordonaro, a cui gli eredi di don Giacomo B. vendettero la “Signoria di Canicattì”.
1636 Filippo Bonanno e Balsamo, primogenito eredita tutti gli Stati appartenuti ai genitori. Sposa Anna, figlia unica di don Agesilao Crisafi, barone di Pancaldo e cavaliere di S. Giacomo, con la quale procrea Giacomo B. Muore nel mese di dicembre dello stesso anno. 1636 Pietro Bonanno e Balsamo, secondogenito. Il primogenito di Filippo, Giacomo, è minorenne. Pietro sposa Violante Notarbartolo. Muore senza prole. La vedova si risposa con Cesare La Grua Talamanca, figlio del principe di Carini, che tiene titolo di duca di Villareale. A questi rilascia la procura per la baronia di Canicattì e Ravanusa. 1637 Dal 18.12.1637, Giacomo Bonanno e Crisafi, primogenito di Filippo, tredicenne. Sposa Francesca Marini dei duchi di Gualtieri. Governa 28 anni. 1666 Filippo Bonanno e Marini, primogenito di Giacomo. Sposa la cugina Rosalia Bosco, figlia ed erede di Francesco, principe di Cattolica, e nipote del Viceré. In seconde nozze Stefania Bosco, figlia del principe di Belvedere. Si noti la vasta rete di baroni e titolati vari di tutta l’isola,con cui i Bonanno erano legati, per vincoli matrimoniali e parenterali. Due fonti battesimali di pregiatissimo marmo monoblocco vengono collocati nelle Matrici di Canicattì e di Ravanusa. Sono identici e riportano scolpito lo stemma dei Bonanno (un gatto nero passante in campo d’oro). Il barone Filippo B. a Palermo ricopre la carica di Governatore della Compagnia della Pace 1671 La baronia di Ravanusa è gestita da Francesca Bonanno e Barresi, duchessa di Montalbano. 1684 Agesilao Bonanno e Crisafi, secondogenito di Filippo B. e Crisafi. E’ il primo duca di Ravanusa per real privilegio del 24.2.1684 (16). 1694 Melchiorre Bonanno, duca di Ravanusa, con real privilegio del 24.2.1694. Ottiene l’investitura il 20.5.1700. 1711 Francesco Bonanno e Bosco. Il più illustre della baronia, per titoli e prestigiosi incarichi. Sposa Isabella Morra che muore senza prole. In seconde nozze Anna Maria Filangeri, da cui nasce F.Giuseppe B. Abita a Palermo, ove è pretore. Morto lo zio Giuseppe Bosco, di cui è erede, prende il titolo “principe di Cattolica”. Muore il 27.12.1739.
4 - LE BARONIE A RAVANUSA (1733 - 1820) 1733 Dal 27 febbraio, Agesilao Bonanno e Ioppolo. 1736 Francesco Giuseppe Bonanno e Filangeri, principe di Roccafiorita (ME) e di Cattolica (AG), duca di Misilmeri e di Montalbano, marchese di Limina, conte di Vicari, barone di Siciliana, Cattolica, Canicattì, Ravanusa, Milici, Mancini, Floresta, Zafferana, Castellana ecc.. Vive a Palermo. A Bagheria costruisce “Villa Cattolica”, oggi divenuta mausoleo di Guttuso e Galleria d’Arte Moderna. Sposa Giustina dei conti Borromeo Grillo e in seconde nozze Maria Teresa Caracciolo Grumo dei marchesi di Napoli. Soggiorna per lo più nella predetta città. 1741 Emanuele Bonanno e Filangeri, dietro procura rilasciatagli dal fratello Francesco Giuseppe per la “terra” di Canicattì e per quella di Ravanusa. 1781 Francesco Antonio Bonanno Borromeo. Sposa nel 1765 Caterina Branciforti e Pignatelli, figlia del principe di Bufera, da cui nasce il primogenito Giuseppe. Ottiene l’investitura il 21 marzo 1781. Muore nel 1797. 1794 Emanuele Bonanno, principe di Cattolica. 1798 Dal 9 Luglio Giuseppe Bonanno e Branciforti, principe di Roccafiorita e barone di Ravanusa. Colonnello del regt. Fanteria “Val di Mazzara” e brigadiere dei Reali eserciti. Sposa Teresa Moncada e Branciforti, figlia del principe di Paternò. Nel 1804 rinuncia spontaneamente ad alcuni suoi diritti feudali (di gallina, di monopolio dell’orzo, del vino e delle nocciole, di trappeto e di fondaco). Riesce a mantenere, ma per poco, solo quello sulla carne macellata. Perde tutti gli altri, su conceria, pelli, formaggi ecc.. E’ l’ultimo principe di Cattolica. L’ultimo dei baroni che hanno governato da secoli Canicattì e Ravanusa. Con lui crollano potere e privilegi baronali, aboliti a furor di popolo. Don Giuseppe Bonanno, nel 1819 era riuscito a vendere, per il canone annuo di 1700 oz., la “Signoria di Canicattì” in perpetua enfiteusi al barone Gabriele Chiaramente Bordonaro. Fece una triste fine. Nel 1820 fu assassinato, a Palermo da alcuni popolani, durante i moti insurrezionali. 1817 La Legge del 18.10 1817 abolì le comarche (Ravanusa apparteneva a alla comarca di Licata, Canicattì a quella di Naro) e istituì i sette Capovalli o Capoluoghi di Provincia. Sei province provenivano dalle città demaniali. Caltanissetta era, invece città feudale. Ad esse si aggiunsero Enna e Ragusa. 1820 Dal 1° Gennaio, Ravanusa divenne Circondario e Comune del Val e Distretto di Girgenti. Nelle elezioni per la carica di Sindaco, Primo Eletto risultò Agliata Melchiorre e Secondo Eletto (subentrava in caso di assenza o di impedimento del “Primo Eletto”), il notaio Francesco Lauricella. I suddetti esplicano anche le funzioni di Ufficiali di Stato Civile, prima demandate al Curato della chiesa parrocchiale (Matrice). Gli eredi della baronia Bonanno mantennero, anche con la nostra Costituzione democratica, il diritto ai titoli nobiliari, già detenuti, alla proprietà dei beni personali o di famiglia (case e feudi) e al patronato in alcune chiese, tra cui la Matrice di Ravanusa in ordine alla presentazione degli arcipreti al Vescovo, prima della relativa nomina. Il predetto patronato oggi è andato in disuso, per espressa rinuncia di essi eredi. Ultimo a subire la procedura del citato diritto di patronato fu l’arc. Don Filippo Messana, nel 1966. Di seguito, elenco gli eredi in causa, di cui ho reperito notizia: - Salvatore Bonanno e Branciforti, fratello del principe di Roccafiorita Giuseppe, barone di Ravanusa. - Francesco Antonio e Moncada, suo primogenito. - Francesco Paolo Bonanno e Moncada. Sposò Vincenza Perez. Morì nel 1888. La baronia passò al figlio minore Salvatore B. e Perez, amministrata dalla vedova. - Antonino Bonanno e Perez. Ereditò i seguenti titoli e diritti connessi: principe di Cattolica e di Roccafiorita, paria del Regno, duca di Misilmeri, Montalbano e Floresta, marchese di Limina, conte di Vicari, barone di Siciliana, Canicattì, Ravanusa, Castellana, Milici, Grasta e Salina Grande nel trapanese. Sposò Adele Chiesa di Vicenza, da cui nacque solo una figlia, Briandra B. e Chiesa. Morì nel settembre 1975. La vedova Adele amministrò la baronia per conto della figlia, sino alla maggiore età della medesima. E fu la suddetta Ved. Adele Bonanno a rinunciare, dietro invito della Curia Vescovile di Agrigento al diritto di patronato nella Chiesa Madre di Ravanusa, dedicata ancora a S. Giacomo, per come aveva voluto il barone Don Giacomo B.che la costruì a sue totali spese.
La solenne festività dell’Assunta del 15 Agosto, nella nostra città, dal decorso biennio è rimasta priva dell’antico miracoloso simulacro della “Madonna di Ravanusa”, in restauro da un notevole lasso di tempo nel laboratorio Vassallo di Palma M, ad iniziativa di un privato (che avrebbe ottenuto la guarigione da male incurabile della madre), con il patrocinio dal Lion Club Ravanusa-Campobello. Ma l’attuale presidente Lion, sig.ra dr. Lina Lauricella ha sbloccato il fermo dei lavori in situazione di stallo, salvando detta statua da sicura distruzione, col dissuadere gli operatori dall’asportazione del panneggio esterno. La stessa ha curato altresì un’apposita delibera Lion per il restauro degli altari lignei del detto santuario, ed è intervenuta presso la Soprintendenza BB.CC. per un progetto di ristrutturazione della chiesa, le cui mura appaiono lesionate, con danno degli storici dipinti della volta. La statua della “Santa Maria di Ravanusa” fu costruita nel 1548, da una bottega artigianale di Licata, in creta rivestita di panno tela e stucco dipinti. Sulla scorta di atti dell’archivio giuratale della sua città, lo documenta L.Vitali, in “Licata città demaniale” (Licata 1909), precisando la distanza di undici miglia da Licata di tale chiesa “S. Maria di Ravanusa”, eretta su terra allora appartenente al territorio di Licata, e con il diritto di patronato dei Giurati licatesi. Anche un’antica stampa, a firma di un incisore tedesco (Inc. Frid. Geise.), rappresenta l’apparizione di “S. Maria di Ravanosa presso all’Alicata” al conte Ruggero genuflesso, durante l’assedio al castello di Ravanusa, da lui conquistato ai saraceni. Il culto tributato alla “Madonna di Ravanusa” non è di recente istituzione, bensì millenario, risalendo in effetti all’epoca normanna, al Conte Ruggero. Questi secondo la tradizione locale, ottenuto il miracolo dell’acqua sgorgata da un fico per dissetare il suo esercito, poi vittorioso sui saraceni, innalzò sul luogo dell’accampamento (nella zona dell’odierno Convento) un tempio a “Santa Maria di Ravanusa” e diffuse tale culto anche a Mistretta e a S. Giovanni La Punta, erigendovi due chiese dedicate alla suddetta “S. Maria di Ravanusa”. Tuttora dai fedeli delle due cittadine la Madonna ivi viene invocata per ogni sorta di grazie come “Beddramatri di Rivinusa”. In antichi documenti e rogiti di Archivi di Sicilia è pure detta “Nostra Signora di Ravanusa”, “Nostra Donna di Ravanusa” o “Madonna del Fico”. Vi era un’antica usanza dei ravanusani, testimoniata da Don Achille Passalacqua, nativo di Mistretta, venuto più volte a Ravanusa, di legare al braccio del predetto simulacro un sacchetto di stoffa, ove i fedeli riponevano appositi bigliettini imploranti le grazie richieste, reiterando in tal modo il comportamento degli ebrei chini sul muro del Tempio di Gerusalemme. L’evento del Conte Ruggero, del pari all’antico culto di “Santa Maria di Ravanusa” va sottratto alla leggenda, per un sicuro continuum di dati storici. Dell’oppidum Remise scrisse il benedettino Goffredo Malaterra, che fu al seguito del Gran Conte, elencandolo tra gli undici castelli da questi conquistati ai saraceni, dopo la resa di Girgenti del 25 luglio 1086. Per la logica vicinanza a Bifara e a Muculufa fu individuato con Ravanusa da Fazello, Natoli, Caruso, Di Blasi, Palmeri a Picone, che peraltro aggiunsero doviziosi particolari sul Conte e sul cugino Palmeri che per primo ottenne in baronia casal Ravanusa e sulle armi tolte ai musulmani nella battaglia di Monte Saraceno e custodite nel Castello di Canicattì, sino al tardo Ottocento. Il P.Alessio Narbone, nell’Istoria della Letteratura siciliana (PA 1857, pp. 259-263), menzionò pure i molti “sacrali edifici della normanna religiosità e munificenza innalzati per ogni dove al culto”. Casal Ravanusa esistette nel 1086. Dalla baronia del Palmieri passò al berbero Abdisaleno, e poco dopo il 1154 fu comprato dal vescovo Gentile di Girgenti. Nel Censuum Indiculus del 1177 e in Rationes decimarum dell’archivio vaticano, del 1308-1310, pubblicato da P.Sella (Roma 1954) viene ampiamente menzionata “S. Maria de Revenosa” e un “Presbiter Blasius”della medesima chiesa che pagava le decime per sé e per la detta chiesa. Casal Ravanosa venne venduto nel 1333 dal vescovo di Girgenti Ubaldi a Goffredo Curatore di Messina, arrendatario dei beni della Chiesa girgentina. Finì nel 1336 nelle mani dei Tagliavia, poi di altre baronie sino al De Crescenzo che nel 1421 vi costruì un convento e una chiesa, che affidò nel 1452 ai Canonici di S. Giorgio in Alga. Nel 1709 fu ceduta ai Minori Osservanti. Il Casale con la baronia Bonanno ch’ebbe la licentia populandi divenne “Terra” e quindi “Ravanuse Universitas”. Quanto al culto della Beddramatri di Rivinusa, non può tralasciarsi un cenno al Palio di Santa Maria di Ravanusa, che dal 1621 vi si correva, come a Siena, con il contributo della città di Licata per gli acquisti dei relativi stendardi e trombe. Dell’“ecclesia di S. Maria di questa terra” (Ravanusa), così intitolata si ha conferma nella relazione di visita pastorale del 29 dicembre 1677, del Vescovo Rhini che “accedit in terram Ravanusae…” e “visitat ecclesiam sub titulo S. Mariae de Ravanusa”. Pure nel rivelo del 1714 dell’Universitas di Ravanusa, tra gli Esiti vengono pagate “oz. 16 al Ven.le Convento di S. Maria di Ravanusa” e “oz. 10 per la festività della SS.ma Vergine di questa suddetta Terra in ogni 15 agosto”. Una stampa edita nel 1776 dal p. guardiano OFM F.Ministeri, infine, riproduce fedelmente l’effige di S. Maria di Ravanusa della statua di laterizi del 1548 di Licata: “Vera effigies perantiqua ac lateritie B.V.Terre Populique Ravanuse Patrona principalis, que ibi colitur in Ecc. FF. Minorum”. Su “S.Maria di Ravanusa”, attingendo a rari incunaboli, riferisce altresì P.Ottavio Gaetani in Vite dei Santi Siciliani (Pa 1664). Dopo il miracolo dell’acqua concessogli dalla Divina Madre, il Conte Ruggero, dissetate le truppe, prese ed espugnò il paese, scacciandovi i Saraceni e “in monumento del beneficio, eresse il tempio alla Santissima Vergine; la tradizione e la voce comune ci attestano tali fatti, ed eziandio la pittura, poiché nella Chiesa medesima di Nostra Donna si rappresentano dipinte queste azioni, e acciò non si cancellassero da ingiurie del tempo sono state restaurate”. Tale testimonianza dell’illustre agiografo è preziosa, riguardo alle pitture parietali del tempio di Ruggero “Nostra Donna di Ravanusa”, anche di autore a noi ignoto, già restaurate negli anni in cui il Gaetani visse. Nel 1840, purtroppo, chiesa e Convento furono distrutti da una frana, che tuttora silente rode la parte bassa del paese. Il novum oppidulum Ravanusa, costruito da Filippo Bonanno nel 1617 e la sua antichissima Chiesa, dedicata a S. Maria dal primo Conte di Sicilia, sono anche menzionati dal Pirri in “Sicilia Sacra” (Venetiis 1733, p. 761): “Ruggero combattendo sul monte Sarurio (sic) distante mille passi.. supplicava la Madre di Dio, e…sotto un fico subito sgorgarono acque, sino ad oggi perenni. Ottenuta la vittoria sul nemico, stabilì di costruire un sacro tempio alla Madre di Dio” . Vito M.Amico nel “Lexicon Topographicum Siculum” (CT 1759), alla voce Ravanusa: aggiunge che è un “Paese molto celebre per una chiesa costruitavi alla B.Vergine dal Conte Ruggero …L’antico tempio poi della Madonna, giusta la voce comune costituito da Ruggero, appellasi dal fico, poiché … piantata sotto l’albero di un fico la tenda del Conte Ruggiero dove avvenne l’apparizione della Vergine, ed esserne sgorgata alle radici la fonte, che ancora rimane, somministrando affluentemente delle acque per ogni uso degli abitatori; vedesi perdurare ai nostri giorni il tronco dell’albero e mostrasi ai viaggiatori nel convento dei Minori; dicono aversi il Principe nella sua cappella domestica una immaginetta della Vergine fatta del medesimo legno. Quel Convento, intitolato a S. Maria… è degli Osservanti di S. Francesco; il fondò De Crescenzio Signore del feudo di Ravanusa, e concesselo nel 1453 ai Canonici in Alga…Vi si venera nella Chiesa un simulacro della B. Vergine, creduto di bitume e splendido per la gloria dei miracoli, la cui festività si celebra con fiere e gran concorso di popolo nel giorno del 15 Agosto” . Concudendo, i toponimi di quartiere e strade “S.Maria di Ravanusa”, riscontrati nei “Riveli di Ravanusa”, dal 1623 al 1798 e nei registri di anagrafe del suo Stato civile riguardano case abitate “in contrada Nostra Signora di Ravanusa”, nel “quartiere di S. Maria” o così intitolate “Della Madonna, della Madonnuzza, della Madonna del Fico, del Convento e di Ruggero, Rabatello e Fondaco”. Riguardano, altresì delle nostre contrade Cammuto (emiro Hamûd), Palmeri (cugino del Conte) e una regia trazzera La Grazia. Le voci dialettali arabe, per usare le medesime parole del Picone sono i veri e “autentici monumenti della Storia arabo-girgentina”, ancora tutta da studiare, direttamente sui codici antichi, in parte intonsi. La Parrocchia Matrice “S. GIACOMO” di Ravanusa fu fondata, a totali spese e con diritto di patronato dal barone di Canicattì e Ravanusa Don Giacomo Bonanno e Colonna, e costituita per Atto del Notaio Pietro Buscemi Senior di Agrigento del 29 gennaio 1632. Le rimanenti parrocchie vennero erette dopo oltre tre secoli, con decreti vescovili. La S.Croce e S. Michele nel 1935, la B.M.V. di Fatima nel 1955 e la Sacra Famiglia nel 1986. 1 - NICOSIA Antonino (1632-1936) prestigioso capostipite degli arcipreti della nostra città, qui appresso elencati, nativo di Mirto (ME), terra baronale dei Bonanno, era peraltro laureato in Utroque Jure. Venne a Ravanusa, come curato, quand’essa non era terra, ma solo feudo e casale, l’8 giugno 1619, al seguito del barone Don Giacomo, che ne aveva ottenuta l’investitura. Fu quindi presente alla riunione del 24 agosto 1621, nella chiesa “S. Maria Ravanusa” dei Canonici di S. Giorgio in Alga (la chiesa parrocchiale al Cassero di fronte alla castellanìa era chiusa per lavori di ampliamento e ristrutturazione), tra il predetto barone e i primi terricoli, trasferitisi dai territori circonvicini per le allettanti garanzie di cessione dell’abitazione e dei soccorsi baronali in denari, sementi e attrezzi agricoli. E risulta tra i firmatari del delle tasse ivi concordate, imposte e da imporre agli abitatori della nuova Terra. Su presentazione del summenzionato barone, nonché principe di Cattolica, Don Nicosia, fu nominato arciprete della Terra di Ravanusa, con bolla del vescovo del Vescovo di Agrigento Mons. Francesco Traina del 20 febbraio 1632, primo beneficiale della rendita delle 40 onze annuali e censuali sul bilancio della terra di Ravanusa (il 5% della previste 800 once di quell’anno), con il solo obbligo fatto all’arciprete in causa di devolvere ogni anni per la Traslazione di S. Gerlando un rotolo di cera, in segno di sudditanza al presule della diocesi agrigentina. La sua arcipretura durò ben poco. Nel 1637, poco dopo la morte del barone e duca Don Giacomo Bonanno la matrice S.Giacomo ebbe un nuovo arciprete. 2 – D’AUREA Pietro (1637-1663). Manca di questi la bolla episcopale di nomina, per cui ne sconosciamo provenienza e data precisa della presa di possesso dell’arcipretura. Sappiamo però che per l’acquisito diritto di patronato, l’atto di elezione e di prenotazione dei nominativi degli arcipreti continuava a spettare anche in futuro ai baroni Bonanno. E già nel 1621 diversi D’Auria figuravano tra gli abitatori della nuova Terra di Ravanusa. Alessandro, Filippo e Giuseppe D’Auria furono presenti alla prima riunione con il barone don Giacomo del 24 agosto 1621. Il nostro arciprete Don Pietro poté appartenere ad una di quelle famiglie, da allora insediate a Ravanusa. Anche tra i Riveli della Terra di Ravanusa del 1651 è presente tale Francesco D’Auria capo di casa con 6 Anime. E in quelli del 1748 Vincenzo D’Auria di Marco Antonio capo di casa con 4 anime e possiede una casa ove abita. Ancora oggi nella nostra cittadina cospicuo è il numero delle famiglie D’Auria e Auria che vi risiedeno. Nel periodo dell’arcipretura D’Auria si ebbe, dal 6 al 7 giugno 1655, il sinodo diocesano nella cattedrale agrigentina. Per la città di Licata fu presente il delegato del prevosto Rocco Trainiti (1649-1666) D. Francesco Averna, e per l’«oppidum» Ravanusa il delegato dell’arciprete D’Aurea, Don Melchiorre La Mantia, probabile suoVicario cooperatore.
3 – L’AVVENTUROSA VITA DEL REV. NICOLO’ SERPETRO
- Scrittore, poeta e peregrino al sevizio di mecenati – Appassionato d’astrologia e di scienze occulte - Processato a Palermo fu condannato dalla Santa Inquisizione di Sicilia fortunatamente solo all’abiura de levi e all’esilio per tre anni da Palermo e Messina – Arciprete a Ravanusa dal 1663 al1668, nel predetto anno ivi morì ed ebbe sepoltura in Chiesa Madre -
Nicola Giovanni Serpetro è nato nel 1606 a Raccuja (ME), terra baronale dei Conti di Branciforti, da Francesco Serpetro e da Domenica Pagano, in una famiglia benestante con quattro figli (Antonino, Nicola-Giovanni, Ursula e Santa). Ebbe imposto il nome di battesimo del nonno materno Nicola Pagano. I nonni paterni e materni abitavano a Montalbano (ME), ducato dei Bonanno, e lì vivevano con i proventi alla coltivazione dei terreni a gelsi. Il padre possedeva casa, vigna e terreni alberati, pure con gelsi. Nella zona dei Nebrodi l’industria della seta era allora assai fiorente, anche perché i Branciforti per incentivarne la produzione provvedevano a rifornire gli abitanti del grano di provenienza da altri loro feudi, barattandolo con la seta. Nel 1660 la predetta industria raggiunse il massimo, ma a fine secolo, ebbe a chiudere i battenti, determinando disoccupazione, povertà e lo spopolamento del territorio. Il nostro Nicola, sin dall’infanzia ebbe una memoria prodigiosa, pari a quella leggendaria di Pico della Mirandola. Tornato a casa, dalla chiesa, ove aveva ascoltato le prediche, le ripeteva senza tralasciarne alcun particolare e spesso le trascriveva per mostrarle al medesimo predicatore. Che le trovava sempre pienamente rispondenti con quanto egli aveva detto. Adulto, mai rileggeva più d’una volta i libri, perché già li aveva memorizzati. Suoi autori preferiti erano Ariosto, Petrarca, Virgilio, Orazio, Omero e Lucano, ma pure di altri mandava a memoria qualche opera, magari parzialmente. Nel 1626 si iscrisse all’università di Padova e come tanti altri studenti, riuscì ad eludere l’obbligo della frequenza dei corsi per il settennio, con attestati di compiacenti testimoni, rimanendo in Sicilia e recandosi a Padova solamente per brevi periodi. Conseguita il 7 maggio 1630 la laurea in utroque jure col massimo dei voti, si trasferì a Roma, ponendosi al servizio del patrizio Pietro Della Valle, insigne poeta, cui aveva indirizzata una lusinghiera dedica della sua prima pubblicazione in versi, “La Fama”. Nell’Urbe governata da papa Urbano VIII, Maffeo Barberini, grande mecenate di artisti e letterati, frequentò le Accademie salottiere e spregiudicate dell’epoca, coltivando prestigiose relazioni con gente di cultura e prelati. In particolare con i membri del sodalizio dei Cavalieri Gerosolimitani Lateranensi e con i Padri Teatini. Preferì, perciò, fissare la sua residenza in una zona centrale della città eterna, ben pago di una stanzetta nell’Osteria della Stella, a Piazza Colonna, nei pressi della Chiesa S. Maria della Pietà. Nel dicembre 1634 subì un infortunio. Un messinese lo ferì accidentalmente alle tempia con due colpi di spada, causandogli una grave amnesia con crisi di furore. Ne guarì grazie alla terapia suggerita dal Campanella, nei suoi “Trattati di Medicina”, riaprendo le ferite da taglio, rimuovendone i corpuscoli estranei e ricucendole, onde farle meglio rimarginare. Nel 1635, il nostro rev. Serpetro si trasferì a Venezia, per mettersi al servizio del nunzio apostolico Mons. Francesco Vitelli, e lì poté continuare le sue relazioni con l’alto clero e instaurare rapporti anche con l’intellighenzia laica del luogo. Tale apertura gli procurò qualche guaio, quello ad es. d’incappare nella cattiva amicizia del libertino Giovanni Francesco Loredan, mecenate dell’Accademia degli Incogniti, vigilato speciale dalla Santa Inquisizione, perché ritenuto patrocinatore della produzione libraria miscredente e oscena nell’intero Veneto. Allorché il detto Nunzio, da papa Urbano VIII, nel 1639, fu nominato anche Arcivescovo di Urbino, Serpetro, ritenendo superfluo il suo servizio, rientrò nella nativa Sicilia. A Palermo trovò senza difficoltà un altro impiego di segretario presso D. Nicolò Placido Branciforti, principe di Leonforte e conte di Raccuja (terra sua natale), r prese dimora nel medesimo palazzo Branciforti accanto alla chiesa del Piliere. E qui ebbe inizio il più brutto periodo della vita del Nostro. Qualcuno, spinto forse da gelosia per la sua ingombrante presenza a palazzo, scoprì le sue pratiche di arte magica, notoriamente illecite e si premurò a denunziarlo alla Santa Inquisizione. Tali accuse furono avallate da tre servitori del Conte, che testimoniarono sulle invocazioni da lui fatte ai demoni per cinque ore, utilizzando un cerchio di legno, col cambio del demone ad ogni ora, sulla scorta di formulari tratti da appositi libri. Due di tali servitori aggiunsero ch’egli si era vantato di essere edotto in magia e astrologia delle quali era in grado di insegnarle all’Università e, altresì, di avere scoperto rimedi infallibili, per ottenere favori dalle donne, riportati da lui anche nel suo trattato “De horis et virtutibus planetarun”. Per tali infamanti delazioni fu arrestato, condotto in carcere e processato. Il nostro rev. Serpetro si seppe abilmente difendere da raffinato giurista, dichiarando agli inquisitori che aveva letto i libri di negromanzia e di invocazioni ai demoni, ma solo a motivo dei suoi studi in utroque jure, avendone conseguita a Padova la laurea. Tali libri, però, gli erano stati confiscati e bruciati a Venezia, mentre era al servizio del Nunzio apostolico Mons. Vitelli, che lo aveva allora anche assolto da quella colpa. Giurò ancora, persino che mai aveva invocato il demonio né esercitato arti diaboliche, a cui non aveva assolutamente creduto e continuava a non credere e se talvolta, si era vantato, per come sosteneva l’accusa, di astrologia e di scienze occulte, lo aveva fatto solo per stupire gli ascoltatori. Mentre era in carcere, fu accusato da due sacerdoti regolari di avere cattiva nomea nel palazzo, perchè conduceva vita scandalosa e non celebrava Messa, e di avere sostenuto in pubblico tesi a favore della mortalità dell’anima. In ordine alla prima accusa il Perpetro si giustificò che non aveva celebrato Messa per un impedimento canonico e che comunque, però, vi aveva assistito quotidianamente e si era pure sempre comunicato. Quanto all’altra, ammise di avere parlato della mortalità dell’anima, ma solo in una citazione di Epicuro, per riferire il pensiero del filosofo, e non il proprio, perché egli era stato e continuava ad essere sempre convinto assertore dell’immortalità di essa. Nell’auto-da-fè di Palermo del 9 settembre 1640, in piazza della Cattedrale, il rev. D. Nicolò Serpetro, di anni 34, nato a Raccuja diocesi di Messina, e abitante a Palermo, comparve in abito di penitente. Gli andò fortunatamente bene, giacché ebbe inflitta solo la pena dell’abiura “sub levi” con l’esilio triennale da Messina e da Palermo. Su tale mite sentenza influirono le credenziali di alti prelati a cui da tempo era legato, assieme alla protezione del conte Branciforti, cointeressato alla tutela del buon nome del proprio palazzo. Trascorso il periodo dell’esilio, il Serpetro rientrò a Palermo, e quivi si dedicò per quasi un decennio alla stesura dei propri scritti. Nel capoluogo isolano, frequentò l’Accademia dei Riaccesi e a Messina divenne socio dell’Accademia della Fucina. Nei suoi interventi, dopo il trauma del menzionato processo, ebbe però più scrupolosa moderazione, tenendosi alla larga da proclami osannanti al rinnovamento operato in Sicilia dalle scienze e da plausi incondizionati ai principi galileani. Nel 1653 i suoi rapporti con i Branciforti, per taluni screzi non noti, si incrinarono. Il nostro Serpetro tentò di acquisire un nuovo patrono nel vescovo di Gerace calabro, Mons. Vicentini, dedicandogli il poemetto adulatorio “Il simulacro delle virtù”, senza. ottenere l’effetto sperato. Ripiegò, quindi, sugli antichi legami con i duchi di Montalbano, nella cui terra abitavano i suoi nonni. E da Don Pietro Bonanni e Balsamo, principe di Roccafiorita e barone di Castellamare del Golfo, nonché capitano della cavalleria di guardia al Vicerè, ottenne l’agognato incarico di segretario. Abitò così nell’aristocratico palazzo della Cattolica, di via Alessandro Paternostro e a Palermo poté trascorrere in pace gli ultimi anni della sua vita, per come scrive il Mongitore, l’erudito canonico palermitano. Questi, però, aggiunge pure, incorrendo in un altro dei tanti suoi gravi errori, che il rev. Nicolò Serpetro mori a Palermo nel 1664, “non sine veneni suspicione”. Da precisi e inoppugnabili documenti, il nostro rev. Nicolò Serpetro raccujense risulta, invece, presente a Ravanusa, quale arciprete dal 1663 al 1668. Di tale incontroverso dato, l’esimia Prof. Melita Leonardi del Dipartimento di Studi Politici dell’Università di Catania ha preso atto, riscontrando su Internet il mio “Frammenti di storia”, felicemente sorpresa dalla imprevista, direi, risurrezione di tale personaggio famoso, cui aveva dedicato gran parte dei suoi studi. La medesima si è premurata a consultarmi per telefono, inviandomi appresso in omaggio la sua pubblicazione sul curriculum del Serpetro antecedente all’arcipretura di Ravanusa (M.Leonardi, Governo, Istituzioni, Inquisizione nella Sicilia spagnola – processi per magia e superstizione”, Acireale-Roma 2005). Mi ha dato così modo di conoscere parte della vita del nostro arc. Serpetro, che ignoravo parimenti a tutti gli altri cultori di tradizioni e storia della nostra città. Devo a Lei se ho potuto colmare la mutila conoscenza del curriculum del coltissimo e geniale rev. Serpetro. E qui mi corre l’obbligo di ringraziarLa per il gentile invio del suo encomiabile volume, che ritengo costituisca il più bel dono fatto anche alla città di Ravanusa e alla sua storia, per i preziosi inediti e poco noti elementi della biografia del nostro arciprete, da Lei portati alla luce. Pochi peraltro sono gli studiosi delle opere del Serpetro. Oltre al Mongitore e alla nostra prof. Melita, ne hanno scritto Giuseppe Mira, Corrado Dollo e i collaboratori di quest’ultimo, appresso citati. Il nostro Serpetro pubblicò le seguenti opere: “La Fama”, Idillio, dedicato a Pietro Della Valle, Ronciglione (VT) 1632; “Il Mercato delle meraviglie della natura ovvero Istoria naturale”, Venezia 1653 (trad. it. della “Thaumatographia naturalis” del medico polacco, Jan Jonston, calvinista e collaboratore del Comenio, Amsterdam 1632, all’Indice dal 1634, ma emendata dal Serpetro, ad uso dei cattolici); “Osservazioni politiche e morali sopra la vita di Marco Bruto”, Venezia 1653. Quest’ultima è la traduzione italiana della Vida de Marco Bruto, senza indicarne l’autore, Francisco De Quevedo, onde avversare il riformismo dell’Olivares e in difesa dell’aristocrazia sicula e dell’alto clero. Inedito è rimasto l’unico manoscritto pervenutoci: “Il simulacro delle virtù”, poemetto in ottave, dedicato al vescovo di Gerace (RC), ms. 72.II.Q.2.7, custodito dalla biblioteca Valentiniana di Camerino. Sono andati perduti: “Il Baco da seta”, “La Geografia” in otto libri, “Imperatorum romano – germanorum series, ac rerum gestarum epitome” menzionati dal Serpetro nel Mercato delle meraviglie; “De horis et virtutibus planetarum” sulla magia, citato dall’accusa nel processo della S. Inquisizione al rev. Serpetro; e il “Discorso sulla Donna”, di cui riferisce il Loredan. L’opera enciclopedica “Il Mercato delle Meraviglie”, mi preme aggiungere, ebbe, invero, un rilevante successo. Paolo Chiarelli nel “Discorso che serve di preliminare alla Storia naturale di Sicilia”, dopo aver citato tra gli antichi siciliani, Dioscoride, Andrea medico palermitano lodato da Plinio, Apuleio Celso di Centorbi e Gerardo Nocito di Sciacca (che stampò a Napoli nel 1511 un testo di medicina), menziona il Serpetro, accostandolo per la levatura europea al dottissimo matematico C.M. Ventimiglia e al celebre astronomo G. B. Odierna: “Nel secolo XVII vantar possiamo Niccolò Serpetro di Raccuia, uomo di singolari cognizioni che stampò in Venezia nel 1653 la sua opera di storia naturale col titolo, secondo lo stile di quei tempi: Il Mercato delle meraviglie della natura overo storia naturale ove, secondo che gli si presenta l’occasione, va notando varie cose attinenti la storia naturale”…e “Il nostro cavaliere Nicolò Serpetro rapporta a questo proposito nella sua Storia naturale a pag. 159, che nelle vicinanze di Leonforte furono ritrovate alcune masse di succino (ambra), che servirono al Principe di detta terra Branciforti per farne dei vasetti assai curiosi”. Di recente i proff. G. Bentivegna, S. Burgio e G. Magnano hanno curato la pubblicazione presso l’Editore Rubbettino 2005, del volume “Filosofia e medicina in Sicilia”, del prof. Corrado Dollo, emerito studioso delle opere serpetriane, con una nuova riflessione storiografica, accostando il Mercato delle Meraviglie al De Venatione et natura animalium del teatino messinese Andrea Cirino, entrambe edite nel 1653 e caratterizzate dall’insistenza del meraviglioso “luogo naturale del diciassettesimo secolo”, soprattutto per la comune linea, definita del “sapere neutro”, perché non apertamente neoterica e neppure dichiaratamente tradizionalista. Il Dollo rileva, altresì, la nota conflittualità di allora dei più dotati ed esuberanti col potere politico locale che purtroppo costringeva costoro all’esodo, come fu per G. B. Nicolosi, G. Ballo e il medesimo N. Serpetro, e alla diaspora, nel caso di G. A. Borrelli. Quanto alla notizia dell’avvelenamento sospetto e della morte del Serpetro, a Palermo nel 1664, pare che sia stata riportata dal Mongitore soltanto e che non trovi riscontro in altri autori. Si potrebbe peraltro spiegare con il fatto che il Nostro per sottrarsi alla poliziesca vigilanza della Santa Inquisizione, si sia eclissato da Palermo senza dare più notizie di sé a persone legate a quell’ambiente. Non esiste ovviamente alcun dubbio. Poi, della sua effettiva nomina di arciprete agli atti della Curia Arcivescovile di Agrigento, e dell’effettivo servizio prestato in tale veste dal rev. Nicolò Serpetro, a Ravanusa dal 1663 al 1668. Di lui, nel presbiterio della nostra Matrice, resta tuttora il fonte battesimale col suo nome, i suoi irrefutabili titoli e con lo stemma araldico del suo ultimo illustre Patrono. Il Rev. Don Nicolò Serpetro fu nominato Arciprete a Ravanusa dal Vescovo Mons. Francesco Gisulfo, con bolla del 16-06-1663, dietro presentazione del barone della terra di Ravanusa Don Pietro Bonanno Balsamo per il diritto di Patronato, ottenuto su tale arcipretura dal padre Don Giacomo Bonanno Colonna nel 1632, per sé e per tutti i propri futuri discendenti. Rilevante personalità ecclesiastica, il nostro Serpetro aveva ricoperto l’incarico di Canonico Lateranense e conseguìto le lauree in Utroque Jure ed in Sacra Teologia. Il suo rapporto con i Bonanno era sempre stato splendido e assai amichevole. Lo documenta lo stemma di quel casato (un gatto nero passante su fondo d’oro), fatto scolpire sul piedistallo del fonte battesimale di pregiato marmo grigio-rosso, tuttora esistente nella nostra Matrice con l’iscrizione: “U.J.D.D. / NICOL. SERPET./ AEQUIT. LATERA./ CAN. HIERA./ ARCHIPR./A.D.1666”: U(troque) J(ure) D(octor) D(ominus) NICOL(aus) SERPET(rus) AEQUIT(um) LATERA(nensium) CAN(onicus) HIERA(solymitanus) ARCHIPR(esbiter) A(nno) D(omini) 1666. Che va tradotta: “Il Dottore in entrambi i diritti Don Nicolò Serpetro, Canonico Gerosolimitano dei Cavalieri Lateranensi, Arciprete, l’Anno del Signore 1666”. Altro e identico fonte battesimale marmoreo, senza alcuna iscrizione però, bensì con il medesimo stemma dei Bonanno ivi scolpito, si trova nel battistero a sinistra nella Matrice di Canicattì, anch’essa allora terra baronale dei Bonanno. L’arciprete Don Nicolò a Ravanusa durò in carica un quinquennio, dal 1663 al 1668, anno in cui morì nella nostra medesima città, per come si legge nella Bolla di nomina del 1668 dell’arciprete Natale Cammilleri che fu suo successore. In ordine al quinquennio dell’arcipretura Serpetro nella Parrocchia “S. Giacomo” di Ravanusa, il caro e fraterno amico Mons. Enzo Gallo, riporta, però date differenti: 16.6.1662-1667. Nei Riveli di Ravanusa ci sono ulteriori testimonianze di nuclei famigliari del Rev. Serpetro trasferitisi in detta terra. Prima della sua arcipretura, in tali Riveli del 1623, 1636 e 1651 non figurano terricoli con tal cognome o similare, mentre in quelli del 1682 e successivi vi risiedono i “Sarpietro” o “Sampietro”. Pur se il cognome è lievemente alterato, i nomi battesimali ripetono quelli dell’originaria famiglia del nostro arciprete: Giovanni, Francesco, Domenica e Santa. ======================================= SULLA VICENDA STORICA DI DON NICOLO’ SERPETRO ARCIPRETE A RAVANUSA DI SALVATORE ARONICA
Nell’edizione riveduta de Il mercato delle Maraviglie di Serpetro (L.Pellegrini Ed., Cosenza 2011), il prof. Santi Lo Giudice dell’Univ. di Messina, alla precedente sua dotta Introduzione aggiunge un capitolo (pp. LXXV-LXXIX) sulla nuova versione della morte di Don Nicolò Serpetro, in cui rileva le testimonianze inconfutabili riferite dal prof. Salvatore Aronica negli articoli apparsi sui numeri 98, 99, 100 e 101 (maggio-agosto 2010) della rivista mensile Lu Papanzicu col titolo L’avventurosa vita del raccujese Don Nicolò Serpetro, scrittore, poeta, astrologo e arciprete di Ravanusa. Fa presente altresì, d’esserne venuto a conoscenza dopo la ristampa anastatica del detto volume (dic. 2009), cosicché in esso il Serpetro continua a figurare morto a Palermo, nel 1664, non sine veneni suspicione, per come scrive il Mongitore. Con tale lacuna la detta ristampa ha avuto anche “due visibilità ufficiali” alla grande. La prima presso l’Aula Magna dell’Univ. di Messina il 28 maggio 2010, alla presenza del Magnifico Rettore prof. F. Tomasello, e l’altra il 28 agosto dello stesso anno al Castello Branciforte di Raccuja. Nulla il chiar.mo professore ha da eccepire sulle argomentazioni di Aronica, che dopo aver “succintamente ed efficacemente” descritto i passaggi nodali della vita e delle opere di Serpetro, riferisce dell’arcipretura del suddetto a Ravanusa, dal 1663 al 1668. In quest’ultimo anno, Don Nicolò morì ivi per cause naturali ed ebbe sepoltura nella Chiesa Madre, come gli altri arcipreti dell’epoca (1). Di tale arcìpretura si hanno ineccepibili riscontri nelle Bolle vescovili, nelle iscrizioni siglate con i suoi titoli e con lo stemma dei Bonanno del Fonte battesimale dal Serpetro eretto nel 1666, ora nel coro della Matrice, e nei Riveli del suo ceppo famigliare, venuto al suo seguito e presentati a Ravanusa. Qualche perplessità, tuttavia, al predetto permane sulla mia ipotesi circa le modalità di affrancamento di Serpetro dalla condanna della S. Inquisizione a cinque anni di clausura. Tale ipotesi della messinscena di morte per avvelenamento è stata, architettata per raccordare l’incarico di arciprete con la condanna quinquennale, di cui sopra, recepita dallo scrivente e dallo stesso Lo Giudice per via di una citazione del Sabìr di Quatriglio, da parte dei raccujesi proff. Carmelo e Francesco La Mancusa, peraltro benemeriti serpetriani, a pagina 20 del loro volume La Vita, “La Fama” e “Il Simolacro della Virtù” di N. Serpetro (Brolo (ME) 2006). Dall’attenta lettura di detto Sabìr, invero, si evince che la quinquennale condanna in causa, al Serpetro non è stata mai irrogata. In Premessa, l’autore precisa che le sei ”storie esemplari” su episodi del passato realmente accaduti, sono amplificate talora fino all’allegoria e taluna è narrata con qualche arbitrio, alla maniera di Borges, essendo suo precipuo scopo ribadirne la denuncia dell’intolleranza e di tutte le inquisizioni. Mi sono premurato anche a consultare per telefono, in data 22 Ottobre 2011, l’emerito giornalista, presso la sua abitazione di Palermo. Ha riconfermato con estrema chiarezza che l’episodio di Serpetro in Sabìr è “un racconto del tutto romanzato”. Bando, dunque, alle surrettizie ipotesi. E surrettizia pare anche quella del chiar.mo prof. sui grandi benefici, lucrati dalla Curia palermitana e dalla baronia Bonanno col solido accordo del do ut des, come ai bei tempi dei vescovi-conti, nel conferire l’importante arcipretura di Ravanusa a un condannato a cinque anni della S. Inquisizione, che alla fine dei conti condannato non era. Quanto alle altre perplessità, esse appaiono fugate dalla inesistente condanna di cui sopra e dalla non clandestina arcipretura serpetriana. La bolla 16 giugno 1663 del Vescovo Gisulfo Osorio attesta la nomina di Serpetro in sede vacante per la morte dell’Arc. De Aurea e la sua elezione e presentazione regolare per diritto di patronato nella Chiesa Madre di Ravanusa del Duca di Montalbano, nel rogito del Not. Luigi Panitteri datato 23 Maggio 1663. Don Nicolò è, altresì ritenuto idoneo, dai Reverendi Esaminatori Sinodali, a ricoprire l’ufficio di arciprete in tutte le funzioni. Per obbedienza e riverenza al Vescovo e ai suoi successori nell’episcopato, gli si fa solo obbligo a devolvere ogni anno, in cattedrale, un rotolo di cera, per la Traslazione di S. Gerlando. Sulla mia ricerca storica serpetriana, che figura da tempo, non contaminata da note della condanna quinquennale dianzi detta, nel mio sito (www.salvatorearonica.com) a cura dell’esimio prof. G. Ferro, nessuna perplessità di sorta è stata mai pronunciata. La rinomata autrice di preziosi volumi su vita e opere dell’illustre raccujese, prof. Melita Leonardi dell’Univ. di Catania, ne ha intessuto addirittura le lodi. Da un suo articolo sul nostro Mago sfuggito all’Inquisizione, del 3.9.1999, in La Sicilia, stralcio un breve brano: “…Mentre, affranti, deploriamo l’amara sorte del nostro eroe e inveiamo contro l’invidia sovrana nelle corti, Internet e non il diavolo, mette il suo zampino. Il prof. S. Aronica, dirigente scolastico e valente storico, ha pubblicato in rete uno studio sugli arcipreti di Ravanusa tra il XVII e XX secolo. In questo vastissimo elenco un nome balza tra tutti. Nicolò Serpetro. Ben lungi dall’essere morto avvelenato a Palermo nella data citata, si trovava, vivo e vegeto a Ravanusa, nel pieno esercizio del suo ufficio di arciprete”. Relativamente alla morte di Serpetro, nel 1664 per veleno, di cui a mio avviso “ha scritto solo il Mongitore e manca di riscontro presso altri contemporanei”, quel “contemporanei va riferito al Mongitore e meglio al Serpetro. Nullo permane l’apporto in merito del dr. Giuseppe Algeri, dal Lo Giudice tirato in ballo, che ne scrive nella Brevissima sintesi della storia di Raccuja, nel 1981, senza citare fonte alcuna o documentazione. Sul diritto di vita e di morte sopra i “terricoli”, concordo col prof. Lo Giudice ch’esso “era prerogativa di re, imperatori e pontefici”. Tranne nei casi di cessione o vendita di tale potestà, da parte di sovrani, ad es. di Filippo III e Filippo IV di Spagna e loro Vicerè. Ne dissertano ampiamente il La Lumia e il Bianchini (2). I baroni siciliani, invero, con la concessione o acquisto del “mero e misto impero” potevano disporre a modo loro della vita e sostanze dei terricoli e condannarne i rei, fino all’ultimo supplizio. Emblema di tale potente dominio era la forca eretta all’ingresso del loro temuto maniero (3). Don Giacomo Bonanno comprò il mero e misto impero sulla “terra” di Ravanusa dalla Regia Curia, per 6.000 onze, con Atto del Not. A. La Curuna del 14 Luglio 1621 (4). Il Vescovo Mons.Traina, nel dicembre 1648, acquistò il mero e misto impero sulla città demaniale di Agrigento per 40 mila scudi e quello sulla città demaniale di Licata per 50 mila scudi, dal Vicerè Card. Trivulzio (5). E allorché Licata venne riscattata dai nobili Buglio e Cipolla, e il Tribunale del R. Patrimonio il 23 marzo 1650 ne riprese possesso, lo stesso giorno furono abbattute le forche che Mons. Traina, in segno del suo potere aveva innalzato nel piano della porta maggiore della città (6). A Ravanusa pure i Bonanno innalzarono le forche. Ne rimane il toponimo Piano delle Forche di una contrada nel pianoro di M.Saraceno sulla provinciale per Riesi. Altro toponimo di analoga contrada Le Folche trovasi a Canicattì. Vi si giustiziarono diversi briganti. Nel concludere, intendo sottolineare che anche il chiar.mo prof. Santi Lo Giudice, non si esime comunque, a chiusura del nuovo capitolo, aggiunto alla sua Introduzione nel Mercato delle Maraviglie, dal tessere un giudizio assai lusinghiero, nei miei riguardi. Nel riportarne le testuali parole, Lo ringrazio sentitamente e doverosamente per tanto: “A parte le ragioni del metaracconto, riteniamo lodevole il lavoro di Aronica per quanto riguarda la ricerca e la successiva pubblicazione dei dati riconducibili al vissuto ravanusano di Serpetro in qualità di Arciprete”. ----------------------------- (1) S. Aronica, Cripte cimiteriali nell’antica Ravanusa, La Vedetta, Gen. e Feb. 1999. Nel salone della Matrice si custodiscono le lapidi tombali degli arc. Lentini (1789) e Gallo (1794), da me scoperte nel retro d. Altare Magg., tuttora inedite. Nei Framm. Registri al n. 144 figura il Rev. S.T.U.J.Dr Sac. F. Lauricella, di anni 31 e mesi 5 (prozio dello storico omon.) morto il 19 agosto 1822 munito dei Sacramenti e sepolto nella chiesa S. Michele, per intervento del Clero Secolare e Regolare. Le ossa di Serpetro, per ragioni sanitarie, come quelle degli altri arcipreti e fedeli finirono nell’ossario comune del cimitero di Ravanusa. (2) Lodovico Bianchini, Della Storia economica di Sicilia, Lib.I. Cap. III, Napoli 1841. Isidoro La Lumia, Storie Siciliane, Vol. III, Palermo 1881-1883. (3) Luigi Vitali, Licata città demaniale, ristampa, Licata 1998, p. 6) (4) ASPA stanza I, vol.16932, c 326 r, in Atto del Not. La Valle, datato 19.07.1621. (5) L. Vitali O.c., p. 166. (6) Ibidem, p. 175, in nota n. 1.
======================================= Il mago sfuggito all’Inquisizione di Melita Leonardi Articolo e immagine tratto dal giornale “La Sicilia” di Giovedì 3 Settembre 2009
Non fu veleno ma finì di morte naturale Nicolò Serpetro prete e scrittore nato a Raccuia nel 1606 Molti anni fa, ebbi la ventura di imbattermi in Nicolò Serpetro, una straordinaria figura di sacerdote, scrittore, accademico, mago, virtuoso della memoria, traduttore e segretario di principi, duchi e cardinali. Era nato, nel 1606, a Raccuia, un paesino arroccato sulle montagne nel messinese. Borghese, poté studiare grazie all’aiuto di ricchi e influenti protettori. Pare che il giovane avesse capacità mnemoniche sbalorditive che, all’epoca, suscitavano una morbosa attenzione legata alla sospetta conoscenza di arti occulte. Nel 1630, l’ambizioso Serpetro si laureò, in diritto, presso l’Università di Padova e iniziò le sue inquiete peregrinazioni per la penisola italiana che lo portarono ad intrattenere complessi rapporti di patronage con noti personaggi dell’epoca. Dimorò, infatti, a Roma sotto la protezione di Pietro Della Valle, esponente della nota famiglia patrizia e scrittore, in tarda età, di famosi ricordi circa un periglioso viaggio in Oriente. Fu, ancora, segretario di Francesco Vitelli, cardinale e nunzio presso la Repubblica di Venezia, città della quale il poligrafo siculo poté apprezzare il clima culturale “libertino” legato alla figura di Giovanni Francesco Loredan. Tornato a Palermo come segretario dell’aristocratico Nicolò Placido Branciforti, principe di Leonforte, fu processato, per superstizione, dall’Inquisizione spagnola. Condannato ad un pena mite, Serpetro, da quel momento, adottò un basso profilo che gli consentì di sfuggire a nuove attenzioni del Sant’Offizio. Nel 1653, pubblicò, a Venezia, due libri importanti. La prima opera, Il Mercato delle maraviglie della natura ovvero Istoria naturale, è la traduzione in lingua italiana di Thaumatographia naturalis di Jan Jonston, un medico polacco. Questo manuale di scienze aveva conosciuto un grande successo nell’Europa protestante. La seconda opera pubblicata dal nostro autore, Osservazioni politiche e morali sopra la vita di Marco Bruto, è la traduzione in lingua italiana della Vida de Marco Bruto di Francisco de Quevedo, poeta e scrittore tra i più celebrati nella Spagna barocca. Si tratta di due operazioni che vanno, comunque, al di là di una semplice traduzione. Siamo di fronte a veri e propri adattamenti che tengono conto del coevo clima culturale e politico in Spagna e in Italia. Dopo altre disavventure, troviamo l’ermetico raccuiese in stretti rapporti con la famiglia Bonanno, principi di Roccafiorita. Presso la splendida dimora palermitana di questi ultimi sarebbe morto, come afferma un antico repertorio biografico, nel 1664, con un risolutivo aiuto da parte di nemici gelosi. Mentre, affranti, deploriamo l’amara sorte del nostro eroe e inveiamo contro l’invidia, sovrana delle corti grandi e piccole, Internet, e non il diavolo, mette il suo zampino. Il prof. Salvatore Aronica, dirigente scolastico e valente storico, ha pubblicato in rete uno studio sugli arcipreti attivi nella città di Ravanusa tra il XVII e il XX secolo. Ovviamente, in questo vastissimo elenco, un nome balza tra tutti. Nicolò Serpetro, ben lungi dall’essere morto avvelenato a Palermo nella data citata, si trovava, vivo e vegeto a Ravanusa, nel pieno esercizio del suo ufficio. Fu nominato arciprete dal vescovo Francesco Gisulfo, con una bolla del 16 giugno 1663, dietro presentazione, per diritto di patronato, di Don Pietro Bonanno Balsamo, barone della terra di Ravanusa, nonché principe di Roccafiorita. L’arciprete raccuiese, durante la sua reggenza, donò alla chiesa della cittadina un bel fonte battesimale in marmo, ancora oggi esistente, che reca lo stemma dei suoi protettori e il suo nome. Morì, nel 1668, nella piccola terra dell’agrigentino, come si legge nella bolla di nomina di Natale Cammilleri, suo successore nella carica. Nicolò Serpetro, con la sua vasta esperienza del mondo, aveva capito che l’aria, a Palermo, poteva essere, nonostante l’amenità del luogo, poco salubre e aveva chiesto, al suo patrono, la grazia di una sinecura in una tranquilla provincia per trascorrervi, finalmente lontano dal clamore e dall’emulazione, gli ultimi anni della sua vita. 4 - CAMMILLERI Natale (1668 - 1670). Proviene dalla città di Naro. La quale era Città regia o demaniale parimenti a Licata. Ravanusa, prima “oppidum”, borgo o casale, con la licentioa populandi ottenuta da Don Giacomo Bonanno era divenuta “Terra baronale”, come Canicattì. La breve arcipretura biennale non consentì a Don Cammilleri di lasciare a Ravanusa ampia traccia. Invero i nostri concittadini hanno poco curato gli studi storici di tal settore, ove si eccettui Mons. A. Noto, che mi ha avviato agli studi Storia sacra. Custodisco gelosamente la dedica di suo pugno sul frontespizio del volume “Ravanusa, novecento anni di storia”: “Al Direttore Dott. Salvatore Aronica con tanti auguri perché il sua amore a Ravanusa si realizzi in uno studio sull’archeologia di Ravanusa. Ravanusa 1.XII.1985 Can. Angelo Noto”. 5 - COSTANZO Diego (1671-1686). Nativo della Terra baronale di Canicattì, ebbe modo d’essere conosciuto dai Bonanno che avevano preferivano abitare al piano nobile del Castello normanno di Canicattì, anziché nella castellania di Ravanusa. Fu nominato il 10 giugno 1671, dal Capitolo, in sede vacante, per la morte del Vescovo Mons. Ignazio De Amico. Dalla bolla capitolare di nomina risulta che fu dottore in Sacra Teologia e in Utroque Jure. Fu presentato dal Patrono Donna Francesca Bonanno e Barresi, baronessa di Canicattì e di Ravanusa, principessa di Cattolica e duchessa di Montalbano. E nel 1686 venne trasferito da Ravanusa nella Matrice di Canicattì, con il medesimo incarico di arciprete, restandovi sino alla morte, avvenuta nel 1688. 6 - MARINO Antonino (1686-1688). Nella sua bolla di nomina si legge ch’era siracusano. Mons. F. Rhini prima di Agrigento era stato Arcivescovo a Siracusa e pare che l’abbia scelto proprio Lui per la nostra Matrice, appena l’arcipretura fu libera per il trasferìmento del Costanzo a Canicattì. Col decesso del suddetto, nel 1688, pure il Marino finì all’arcipretura di Canicattì e vi permase sino al 1694. Ritornò, quindi a ricoprire il posto di arciprete a Ravanusa sino al 1704. Anche i famigliari dell’arciprete Marino si stanziarono a Ravanusa, e vi risiedono tuttora. Da un rivelo di Ravanusa del 1714 sappiamo che vi abitava Angelo Marino e che il suo nucleo famigliare era costituita da cinque componenti. Dai riveli del 1748-1753, risultano residenti a Ravanusa, i Marino: “ Antonino (Fuoco 1, Anime 7, Casa 1 nel quartiere S. Rosalia), Carmelo (F. 1, Anime 3, Case 2 nel quartiere Matrice) e Luciano (F.1, Anime 2, Casa 1 nel quartiere della Madonna)”. A fine Ottocento nacque a Ravanusa il Sac. Carmelo Marino (1838-1919), Professore nel Collegio dei Santi Agostino e Tommaso di Agrigento, poi nel 1898 Vicario Foraneo di Ravanusa e il fratello Luigi Marino (1847-1912), celebre cattedratico di filosofia all’Univ. di Catania cui la nostra città ha intitolato una strada ed elevato un monumento con busto in bronzo. Attualmente alla nostra anagrafe comunale figurano le famiglie Calogero, Carmelo, Dina, Emilia e Vito Marino. 7- FERRO Giovanni (1689-1704). Nominato dal Vescovo Mons. F. Rhini, il 3 Ottobre 1689, a seguito del trasferimento del Marino a Canicattì, risulta dalla relativa bolla Abate Beneficiale e Dottore in Utroque Jure e in S.Teologia. 8- SANCHEZ Antonino (1705-1722?). Nella Bolla di nomina, a seguito del decesso dell’arc. Marino avvenuto il 27 Ottobre 1704, siglata dal Can. Girolamo Turano, in assenza dell’Arcivescovo Mons, F. Ramirez titolare della diocesi di Agrigento, figura proveniente dalla “Terra” di Canicattì e Professore di Sacra Teologia. Eletto e presentato dai Patroni Bonanno, prese possesso nella Matrice S. Giacomo il 12 febbraio 1705. 9- VALENZA Domenico (1722-1722). Manca la bolla della sua nomina. Vi si accenna nella Bolla del successore Don Turturici, precisando che il predetto “succede al Sanchez, per la morte in Canicattì di Don Domenico Valenza, suo ultimo e immediato successore”. Di “Valenza”, però, nella Terra di Ravanusa ce ne furono a iosa, pure giurati. 10- TURTURICI Gaspare (1722-1728). Proviene dalla Terra di Cattolica (cui nel periodo fascista si aggiunse “Eraclea”). Venne nominato il 24 Luglio 1722 e rimase in carica a Ravanusa sino al mese di maggio 1728. Fu, quindi, trasferito nella Parrocchia S. Pietro di Agrigento, ove fu parroco per 24 anni, sino al 1752. 11- COSTANZA Stefano (1728- 1735). Proviene dalla terra di Canicattì. Fu nominato senza elezione da parte del Patrono, per una norma decretata, ad Avignone, da papa Giovanni XXII. Quando la successione non era dovuta a decesso, bensì a trasferimento del predecessore la nomina dell’arciprete spettava alla Santa Sede. Alla sua Bolla di nomina, sono infatti allegate le credenziali Lettere Apostoliche del 14 Marzo 1728 di papa Benedetto XIII, indirizzate al Referendario della Segnatura della Chiesa agrigentina che concedono al Presbitero S.Costanza la facoltà di essere nominato arciprete per la traslazione del predecessore G.Turturici 12- PALUMBO Pietro (1735-1755). Nativo di Canicattì, alunno del Venerabile Collegio agrigentino di S. Agostino e S.Tommaso prese possesso dell’arcipretura di Ravanusa il 7 Marzo 1735, permanendovi sino al 1755. Trasferito a Canicattì come arciprete vi rimase sino al 1779, probabile anno della sua morte. 13- LENTINI Nicolò (1755-1789). Non fu eletto per diritto di Patronato dai Bonanno, bensì nominato con “Lettere Apostoliche”, in allegato alla Bolla, secondo la normativa di papa Benedetto XIV, l’arcipretura nella Matrice S. Giacomo di Ravanusa, era sede libera per trasferimento del predicente arciprete ad altra sede. Prese possesso il 17 Aprile 1755, divenendo così il primo arciprete ravanusano, seguito in graduatoria dall’arciprete M. Gallo. Che fosse appartenente alla Terra di Ravanusa, risulta dal “Rivelo” da lui presentato nel 1753: “Rivelo di beni che fa il Suddiacono Don Nicolò Lentini della terra di Ravanusa, figlio del Notaio Don Gioacchino e di Donna Giuseppa Lentini Coniugi, con giuramento in esecuzione dell’ordine dell’Ill.ma Deputazione di questo Regno del 23 Agosto X Ind. 1747”. In esso dichiara terreni, vigneti, un palmento scavato in una grotta a Monterosso e “n. sei case provviste di cortile, pozzo stalla ed annito in questa terra e quartiere di S. Antonio Abbate (sic!) vicino le case del Notaio Gioacchino Lentini e di Gandolfo Sazio per uso di propria abitazione”. Dagli atti notarili rogati a Ravanusa dal padre, di cui riferisce il Not. A. Rizzo (1782-1784), e dalla sua lapide da me scoperta nella nostra Matrice (vi si legge “Hic iacet archipresbiter Nicolaus Lentini ecc.. Obiit VII Julii 1789” ), si ha conferma che la famiglia Lentini da tempo abitasse a Ravanusa. 14- GALLO Mariano (1789-1794). Nacque a Ravanusa nel 1761. Fu Professore di Sacra Teologia e a Ravanusa ricoprì l’incarico di Presbitero Economo della Chiesa Madre. Il 17 ottobre 1789, eletto e presentato, dal Patrono Barone Francesco A.Bonanno, prese possesso dell’arcipretura il 14 marzo 1790. La mantenne fino alla morte, avvenuta il 30 settembre 1794, a trentuno anni. Fu sepolto nella nostra Matrice. Ne fa fede la lapide, che elogia la probità e onestà della sua vita, zelante e caritativa, fatta da me custodire, assieme a quella del Lentini, in un armadio del salone della chiesa Madre. 15 - CORSO Pompeo (1794-1838). Nato a Ravanusa, ordinato presbitero, conseguì le lauree in Sacra Teologia e in Utroque Jure e nel 1790 fu inviato come arciprete a Caltabellotta, nella monumentale chiesa dell’Assunta eretta dai Normanni, in un fantastico paesaggio rupestre dominato dai granitici “Pizzi”. Dopo qualche anno, ottenne la nomina di arciprete a Ravanusa, il 13 novembre 1794, dietro presentazione del Patrono Emanuele Bonanno. E quivi esplicò la sua attività pastorale per oltre un quarantennio sino alla morte, avvenuta nel 1839. Per la nostra isola quello fu un periodo triste, classificato per quanto attiene al 1820, come “l’annu di lu ribellu”. La gente mal tollerò che i Borboni avessero ritrattato la costituzione del 1812, voluta da Lord William Bentinck, ed era esasperata per l’esosità delle tasse, e ancor di più per la coscrizione obbligatoria, in un momento in cui il crollo dei prezzi in tutta Europa aveva portato non solo diffusa povertà, ma carestia e fame. Tale “ribellu” cominciò a Palermo nel clou del festino di S.Rosalia, dal 14 al 17 luglio 1820, pure con l’uccisione in uno dei tumulti popolari del 1820 dell’ultimo barone di Ravanusa e di Canicattì don Francesco Bonanno e Filangeri. ne e si estese rapidamente in Agrigento e provincia, ove avvennero tumulti disordini, devastazioni, saccheggi di casa e incendi, come a Cammastra, ove fu arrestatato il parroco di Palma che si era ivi recato per un colloquio col principe di S. Castaldo.A Licata fu occupata la casa comunale e furono bruciati ancora una volta come nel 1553 gli archivi cittadini. Non furono risparmiarti gli ottanta ribelli che avevamo cercato riparo in matrice. Caddero ottanta uomini, Molte altre chiese furono covo, ad iniziativa di singoli preti o laici a loro vicini di vendite carbonare. A Campobello fu saccheggiata la casa del notaro Gaetano Lombardo, fratello dell’arciprete e distrutte le carte dell0ufficio imposte ch’egli riscuoteva. E di peggio accadde altrove. (Ved. D.De Gregorio La chiesa a. o.c., IV, 52). Pure Ravanusa diede il suo contributo. Prete liberale e vicino ai rivoltosi fu il summenzionato arciprete P. Corso. Avuta notizia della costituita Repubblica Partenopea del 24 gennaio 1799 e della fuga dei Borboni davanti alle truppe di Championnet, mentre accompagnava il SS. Sacramento, intonò il Te Deum laudamus!, onde poi, rientrato al potere il tredici giugno il governo borbonico, fu conseguentemente malvisto e perseguitato. Fu pure rinchiuso per quattro anni nelle fosse di Licata e forse salvato in extremis dalla pena capitale dall’amico marchese Arezzo. Ha lasciato il suo nome sulla campana grande della nostra Matrice, fatta da lui rifondere nel 1827 presso la ditta Giuseppe Virgadamo di Burgio. Tale rifusione pare abbia distrutta una precedente iscrizione dei Bonanno, ben solerti a dettare i loro motti e nomi sulle campane delle terre ottenute in baronia. La Matrice di Ravanusa, con i due annessi campanili era stata costruita a totali spese da Don Giacomo Bonanno. L’orologio, per il quale, l’Universitas Ravanusae nel 1714, pagava “4 once e 15 tarì annui di salario all’orologiaio”, se non da lui, fu di certo istallato dal successore barone e duca Agesilao B. e Grisafi. 16 - LONGO Domenico (1839-1856). Nato a Ravanusa, prese possesso dell’arcipretura il 21 marzo 1839, con nomina del Vescovo Mons. Ignazio Montemagno, senza presentazione del Patrono Bonanno, bensì col placet, del regio chirografo di Re Ferdinando II, dato a Napoli il 16 febbraio 1839. Fu arciprete sino al suo decesso che ebbe luogo a Ravanusa nel Marzo del 1856. 17 - CURTI Calogero (1856-1888). Nacque a Ravanusa il 18 febbraio 1818, da una famiglia di burgisi, ricchi proprietari terrieri, nel palazzo di Via Lincoln, menzionato in Guide della Sicilia antica per una collezione di vasi greci e dipinti di scuola Antonelliana, purtroppo dispersa durante l’ultima guerra. Avviato in Seminario, si distinse per doti di pietà ed elevato profitto negli studi, per cui ammessone tra gli alunni del Collegio agrigentino dei Santi Agostino e Tommaso, proseguì per altri sei anni nella specializzazione in teologia morale e in diritto canonico, sotto la guida degli emeriti professori Canonici Cirino Rinaldi e Salvatore Romano, conseguendo presso una Università Statale il dottorato in S. Teologia e in Diritto Canonico. Consacrato Sacerdote il 18-09-1840, venne assegnato a Ravanusa, e qui presto scelto come Vicario Foraneo. Alla morte del Longo, fu Rettore Economo della Matrice e arciprete di Ravanusa con credenziali del regio chirografo di Ferdinando II e bolla del 18 aprile 1856 del Vescovo Domenico Lo Jacono, con cui gli si imponeva di devolvere ogni anno un rotolo di cera per la Traslazione di S. Gerlando e 12 tarì per la cappella del medesimo Santo. Ciò al fine di sancire il dovuto onore e riverenza alla persona del Vescovo e dei suoi successori. Al suddetto Vescovo, invero, il Curti rimase legato da devota e affettuosa amicizia. E da questi ottenne un generoso contributo per la ristrutturazione della chiesa, ch’era stata chiusa nel 1857 dall’Intendente perché pericolante. Lo ricordano una lapide e l’iscrizione sul ritratto ad olio dell’arciprete, custoditi in Matrice. I lavori furono affidati ai capo mastri Giuseppe Bonelli di Licata e Emmanuele Turco di Naro (risulta da un’apoca a loro firma di 200,20 oz.), che costruirono muri di sostegno alla parete destra e impiantarono grossi tiranti in ferro a protezione della volta. Il nostro arciprete provvide altresì la chiesa di nuovi arredi sacri e l’abbellì di un coro in legno. Espletò la propria attività pastorale con zelo e diligenza, sempre vicino ai suoi parrocchiani nelle esigenze spirituali e nei bisogni materiali, elargendo di propria tasca laute elemosine e soccorsi per la seminagione ai contadini. Gli vennero affidati molti incarichi sia da parte ecclesiale che laica. Giovanissimo, nel 1844, ebbe accordata la facoltà di confessare donne, riservata allora ai sacerdoti anziani. Nel 1846 fu Deputato Ecclesiastico delle opere pie laicali e Deputato per le opere di Beneficenza del Comune. Nel 1853 Deputato Ecclesiastico per la riscossione delle rendite della Chiesa Madre e Visitatore delle Chiese. Da Re Ferdinando, infine, nel 1855 fu nominato Delegato della R. Monarchia ed Apostolica Legazia. Fondò la Pia Unione contro la bestemmia, la Pia Unione delle Madri Cristiane e la confraternita delle Figlie di Maria. Di questa, Superiora fu Donna Maria Cannarozzo e Direttrice la sorella Dorotea Curti (Donna Dia), nota per le proverbiali ricchezze, decantate pure dai contadini del luogo: “E sempri dunna mi giru, giru, sulu terri di Donna Dia viu”). In Matrice il nostro arciprete curò diversi corsi di esercizi spirituali per le donne il pomeriggio e per gli uomini la sera, oltre agli annuali periodi di predicazione per la quaresima, il Natale, il mese di Maggio e l’ottavario del Corpus Domini, tenuti da padri religiosi di un certo grido, invitati da altri sedi. A sue spese ricostruì in contrada Portella la chiesa rurale “Madonna della Provvidenza” del 1700 (Atto Not. Marchese del 17 sett. 1856), per avvicinare ai Sacramenti i contadini di tale contrada. Che vi festeggiavano ab antiquo nella prima domenica di Ottobre, la tradizionale “Purteddra di fora”, fiera dei frutti stagionali, con S. Messa all’alba, banda musicale cittadina, gare, giochi di abilità e scorpacciate. Ad essa seguiva nella domenica successiva La Purteddra d’intra, nel rione S. Croce. Tali iniziative costituivano per il contado una rivincita, originata dal rancore verso baronie e burgisati, che nel passato non consentivano ai coltivatori e mezzadri delle loro terre la raccolta dei frutti degli alberi, riservata in esclusiva ai padroni. Il Curti visse pure d’amor patrio. Insorta Palermo nel 1848, Agrigento ne seguì tra le prime città di Sicilia l’esempio, costituendo i comitati cittadini rivoluzionari e di essi fece parte l’arc. Curti, che professò apertamente idee liberali, in più articoli su Il Cittadino, L’Indipendenza, La Lega. Il 29 gennaio 1848, Re Ferdinando concesse, suo malgrado e con giubilo dei siciliani, la costituzione e il governo dell’isola fu affidato a Ruggero Settimo. Il 25 marzo a Palermo si stabilì il Parlamento Nazionale, in cui per il nostro Comune fu eletto Deputato, allora senza compenso alcuno, l’arc. Curti partecipò a tutte le sedute dimorando in quella sede cinque mesi a sue spese. Nella discussione sull’articolo primo dello Statuto sulla religione di Stato, assieme a Giattini (arc.di Menfi) e ad Amodei (can. di Sambuca), fece, altresì, inserire a verbale il loro voto negativo, per contrastare la formulazione di Ugdulena, “che non accennava alla positiva esclusione dei culti non cattolici ” (Atti autentici del Parlamento Gen. d.Sicilia, Palermo 1848-49, Vol. III pp. 99-100). Rientrato a Ravanusa, il Curti fu eletto Presidente del Consiglio Civico e in tale veste, nella Chiesa Madre, dopo libera mozione tenne adunanza e un discorso, facendo aderire il popolo all’atto del Parlamento sulla decadenza di Ferd. Borbone e sul rigetto della Costituzione di Gaeta. Ciò gli valse, rientrati i Borboni al governo, una sorveglianza poliziesca, la denunzia come cospiratore e numerose perquisizioni. Il 20 maggio 1860 fu finalmente inalberato a Ravanusa il Tricolore della rivoluzione e il Curti, portandolo di sua mano in trionfo per le strade, trascinò il popolo in chiesa, e innalzò il canto del Te Deum, facendo suonare tutte le campane a festa. Benedisse la bandiera della Patria e la onsegnò al Capitano eletto del popolo Giuseppe Pagliarello, primo fautore dell’iniziativa. Il Curti, dal Governatore di Girgenti ebbe pure conferito l’incarico di Presidente del Consiglio Civico di Ravanusa. E in tale veste, il 29 giugno 1860 aprì altra adunanza in Matrice, per tessere le lodi al Dittatore Garibaldi e al Re Galantuomo. L’8 luglio su sua mozione, il Consiglio Civico deliberò l’adesione al Governo Dittatoriale e il successivo giorno 18 inviò una Delegazione a Licata per onorare il figlio del Dittatore, Menotti. Il 18 Novembre del 1860, nominato Primo Deputato della Delegazione Comunale, il nostro arciprete si recò a Palermo per presentare assieme alla detta delegazione gli omaggi al Re d’Italia Vittorio Emanuele. E fu l’ultimo suo atto di liberale. Qualche giorno dopo a Palermo dovette recarsi, ma per starvi a domicilio coatto, impostogli dal Governo di Garibaldi per le accuse, mossegli da un cappellano dell’esercito garibaldino, amico dell’abate Ugdulena, allora Ministro dei Culti in Sicilia. Per il detto cappellano le funzioni di Parroco e la ricca posizione sociale del Curti, erano di ostacolo al nuovo ordine di cose. Con Ord. Min. del 27 dicembre 1860, del Luogotenente del Re Vitt. Em., venuto a Palermo fu, alfine, liberato dalla prigionia. Ritornò a Ravanusa e fu tutta un’ovazione del popolo (D.De Gregorio, La Chiesa Agr. ecc…, o.c ,Vol. IV, p.102-147). Al Nostro, era stata intitolata pure una strada “Salita Curti”, attigua alla Matrice, ora Via Ruggero. Nel 1885, la sua salute cominciò a peggiorare e si dovette far nominare Economo e Rettore della Matrice il Sac. R. Livatino. Così il Curti potè recarsi liberamente a Palermo per esservi meglio curato. Sorella morte lo raggiunse il 3 settembre 1888. Fu sepolto ai Rotoli con un piccolo monumento, distrutto dai bombardamenti della seconda guerra. I suoi famigliari non lasciarono più Palermo e il bel palazzo di Via Lincoln, adibito a edificio scolastico, quindi a caserma di un Reparto di Cavalleria, fu venduto al dr Diego Sciascia e ai Burgio- Noto-Vivacqua. Pure la sua chiesetta, semi diroccata fu venduta ai coniugi Giglia- Aronica che ne fecero un piacevole villino. Nella nostra città dei Curti sono però rimaste le radici liberali, condivise da alcune famiglie di fine Ottocento e di parte del clero locale, dall’arc. Pompeo Corso, ad es. e dal Sac Giuseppe Testasecca, frate osservante, arruolato nel “Battaglione sacro” di ecclesiastici garibaldini. La loro storia di liberalismo è tutta da scrivere (ASA, Atti d’Intendenza 1849; Raffaele De Cesare, La fine di un regno, 1909, Milamo 1860; e Giornale Officiale n. 78 del 6 Aprile 1859).
18. ROSARIO LIVATINO (1888-1918). Nato a Canicattì il 25 febbraio 1847, avviato nel seminario di Agrigento, si distinse per grande profitto negli studi e meritò, come il Curti l’ammissione tra gli alunni del Collegio dei Santi Agostino e Tommaso, fondato dal Vescovo Ramirez per una degna preparazione in S. Teologia e Diritto del Clero. Non conseguì, tuttavia la laurea presso una pubblica Università. Consacrato sacerdote gli fu conferita la facoltà di confessare gli uomini e le donne, solo se inferme. Nel gennaio 1885, onde supplire il Curti, assente spesso per malattia, fu nominato Economo e Rettore della nostra Matrice. Nel gennaio 1889, alla morte del Curti fu nominato arciprete di Ravanusa, presentato ed eletto, per diritto di Patronato dalla Signora Vincenza Perez, ved. di F.P.Bonanno, che invero aveva presentato al Vescovo i due nominativi del Livatino e del Sac, Felice Lo Presti. Il Vescovo Blandini scelse il Livatino a cui, il 15 dicembre 1888, conferì la bolla di arciprete di Ravanusa. L’attività pastorale dell’arc. Livatino è menzionata dalle iscrizioni su lapide e sul suo ritratto e dalle relazioni di visita alla Matrice dei Vescovi diocesani. Sulla lapide leggiamo: “A perpetua memoria / Nell’anno 1903 (non 1905) / offrendosi i marmisti Lombardo / l’arc, Rosario Livatino / vincendo ostacoli mancanze di mezzi / con l’aiuto della Chiesa / del clero locale (costituito da 12 sacerdoti) a gloria di Dio / a ricordo del suo Parrocato / questo pavimento di marno / faceva eseguire soddisfacendoli in diversi anni / nello spesato di lire 3.450”. Tale somma per quegli anni rilevante servì a compensare i lavori annessi alla pavimentazione, tra i quali il trasferimento all’ossario comunale delle sepolture di cui era zeppa la navata della chiesa, per le norme igieniche allora vigenti. Dal ritratto ad olio, riportiamo la scritta, illeggibile nella foto: “B.(beneficia)lis Rosarius Livatino, Canicatteni die 25 febbr. 1847 natus, in Collegio S.S. Augustini et Thomae alunnus; Oeconomus ac Rector huius Matricis Ecclesiae in mense februari 1885 jam renuntiatus; dehinc in mense januari 1889 hanc parrochiam docilitate prudentiaque gessit. Fere omnia restauravit ac pavimentum marmoreum fecit; plura sodalitia fundavit ac fovit. Demum anno Domini 1918 die 24 obiit septembris”. Non è esagerato quel “Fere omnia restauravit”, perché il pavimento della Chiesa rifatto comportò dovuti ritocchi ai muri attigui e agli altari allora in legno laccato e indorato. Sull’altare maggiore innovato si collocò la meravigliosa statua del S. Cuore in legno policromo, con i due angeli alati alti sul basamento in cui figura la scritta colore oro: “VOTO POPOLARE PER L’ANNO SANTO 1900”, sotto la quale un recente restauro ha potuto leggere una precedente iscrizione meglio eseguita in stampatello e nella doratura: “PER COOPERAZIONE DELLA SIGNORA DA MARIA ASSUNTA GALLO FU DN MICHELE NELL’ANNO SANTO 1900”. Ovviamente la menzionata Signora Gallo non avrà onorato tutta somma richiesta dallo scultore, a noi ignoto, e l’arc. Livatino ebbe a racimolare quanto mancava e da qualche artigiano locale fece, quindi, ricoprire la precedente con la nuova scritta di “Voto Popolare”. Tra i sodalizi dal Livatino fondati o incrementati sottolineo : la Pia Associazione del SS. Sacramento, la Congregazione S. Luigi Gonzaga, il Pio Sodalizio delle Madri Cristiane, la Pia Unione delle Figlie di Maria, la “Cassa Rurale S. Cuore di Gesù”, la “Cassa operaia cattolica S. Giuseppe” e la prima Associazione di Azione Cattolica, cui collaborò il Sac. Prof, Mario Musso. La visita pastorale del Vescovo G. Blandini si svolse dal 2 al 12 maggio 1895, con la predicazione serotina per istruire il popolo, mentre durante il giorno effettuava le cresime e le visite alle chiese del Paese e gli oratori privati. La chiesa Purgatorio e quella di S, Antonio Abate erano già chiuse al culto. Si inaugurò, invece la novella chiesa di S. Croce, ben fornita di arredi, paramenti sacri e di tre altari che ebbe nominato rettore il Sac. F. Lo Presti. Un’altra visita pastorale, dal 9 al 16 maggio 1908 fu tenuta dal Vescovo Mons. B. Lagumina. Questi amministrò oltre tre mila cresime, incaricò il Livatino delle visite alla chiesa di Bifara, e in Matrice concesse 40 giorni di indulgenza per l’altare di S. Filomena. L’arc. Livatino, alfine, raggiunse la Casa del Padre il 24 settembre 1918 e la sua salma fu trasferita per volere dei famigliari nel cimitero di Canicattì.
19. ARC. GIUSEPPE SORRENTO. Nacque a Ravanusa il 13 gennaio 1892, primogenito di otto figli, da Calogero, agricoltore benestante e da Calogera Sciangula (la za Cala) figlia di ricchi affittuari di feudi. Avviato nel 1903 nel seminario di Agrigento, fu dai Padri Lazzaristi della Congr. S.V. de’Paoli, che in quel periodo lo dirigevano, educato al rigore etico e alla severità degli studi pure sociologici. In quegli anni conobbe don Sclafani e don Martorana celebri per le battaglie sociali condotte in diocesi e subì il fascino dell’ideologia sturziana. Non ancora ventenne, finì al banco degli accusati del Tribunale di Agrigento, ben difeso dall’avv. F. Parlati di Palermo, per un articolo pubblicato su Il Cittadino in difesa della Religione oltraggiata da politici di sinistra. Ordinato Sacerdote il 13 giugno 1915, fu assegnato a Ravanusa, come Coadiutore dell’arc. Livatino. In parrocchia curò il catechismo per i fanciulli e l’A.C. e nell’ott. ‘18 fondò il circolo studentesco “S.Pellico”, con biblioteca circolante di libri religiosi. Divenne pure Economo della Matrice e deceduto il Livatino, fu nominato arciprete, con bolla del Vesc. Lagumina del 15 mag. ‘19, a seguito d’elezione e presentazione per diritto di Patronato della sig.ra Adele Chiesa. Nel nostro paese allora “rosso vivo”, aprì una sezione del Partito Popolare, subendo minacce e vessazioni. Tramite la coop. del partito lottizzò gli ex feudi Gibbesi e Drasi, e ne assegnò le quote ai contadini. Organizzò inoltre una fanfara di 18 strumenti e il Mov. Giovani Esploratori. Nell’immediato dopoguerra la “spagnola” a Ravanusa, mieté le sue vittime, ma agli ammalati e ai moribondi non venne meno l’assistenza religiosa del nostro arc, cui fu d’aiuto P.Bernardino Di Blasi, ex francescano dal fine umorismo, suo cappellano in Matrice, sino al 1931, anno della morte. Il Nostro nel gennaio 1920, costituì il circ. catt. “S.Cuore di Gesù”, con 45 soci, pres. V. Lauricella, ass. don Vito Costanza. Col cav. G.La Lomia nell’ottobre successivo, fondò la Banca Coop.“La Popolare”. Nella quaresima del ‘22, invitò i PP. Redentoristi (Patruzzzi). Tante le conversioni e molti i fedeli che si accostarono ai Sacramenti. Da Re Vitt. Em. III il 29 ott.‘22, il nostro arc. fu nominato “Cavaliere dell’Ordine della Corona d’Italia”, per benemerenze nel campo delle Società agrarie. Una squadraccia di fascisti, nel sett. ‘23 distrusse il circolo cattolico, appiccandovi nottetempo il fuoco. I giovani, per nulla intimoriti ripresero l’attività, portando orgogliosi la bandiera rovinata dal fuoco nelle adunate diocesane e dinanzi al Duce, il 10 mag. ‘24 in visita alla miniera Trabia. Il periodico Primavera Siciliana del 20-10-1924 sulla sezione S. Cuore di Ravanusa espresse il seguente giudizio: “Provata dalle lotte, ma non doma, mostrò la fermezza degli ideali”. Con fondi della Banca, il Sorrento acquistò locali attigui alla chiesa, che rimise a nuovo per l’asilo e il laboratorio di ricamo delle Salesiane, venute il 18.11.1924. Per i prestiti facili, concessi a tutti, senza garanzie o avalli e per le perdite arrecate dalla gestione di una impresa stradale, la banca dichiarò fallimento. Gli azionisti percepirono dividendi sino al febbraio 1928, rimettendoci oltre il 60% delle somme versate. L’istituto, ove bambino frequentai l’asilo, fu espropriato dalla sig.ra Rosaria Sillitti, zia del cav. La Lomia, e le Suore dovettero trasferirsi nella casina Miccichè, e dopo a casa dei Giuliana in Via Mamiani. Collaborato da don G. Cucchiara, l’arc. Sorrento nel 1924, mise su una schola cantorum. Dotò la chiesa di nuovi arredi e paramenti sacri, e del tabernacolo con calice d’oro massiccio, donando i monili del padre, dei fratelli Angelo e Lillo, delle zie Maria e Vita Sciangula, e raccolti pure presso parenti e fedeli benestanti. Nel 1926, per un delitto d’onore la Matrice fu interdetta. Tale Palma B. ch’era stata abbandonata dal fidanzato Nino T., convolato a nozze con un’altra, lo attese in chiesa (era allora in uso che all’ottava, dopo il viaggio di nozze a Palermo, gli sposini assistessero in prima fila alla S.Messa del mezzodì) e finita la S.Messa gli sparò a bruciapelo, uccidendolo. Il nostro arc. si premurò di farla riconsacrare per restituirla al culto. Volle che la festa del S. Cuore nell’ultima domenica di agosto si svolgesse con la massima solennità. Mai mancò la banda musicale, la rietina di carri e muli con “armici” e carichi di grano, e i fuochi d’artificio. La famiglia Sorrento donava ogni anno “due carri di grano”: uno per la festa e l’altro per i bisogni cultuali della Chiesa. Nelle due visite pastorali alla Matrice compiute personalmente dal Vesc. Peruzzo, nel 1934 e nel 1937, questi nulla ebbe da eccepire, lodò anzi l’attività pastorale del nostro arc. e del clero. Nel 1935 il Nostro ristrutturò ab imis le mura, col concorso del Comune. A sue spese e col raccolto tra i fedeli, rinnovò il prospetto e l’altare maggiore in marmo, e adornò la Chiesa di quadri e di stucchi del Guglielmino. Per il deficit bancario e gravi suoi motivi tali attività cessarono. Il Sorrento si dovette difendere presso il S. Ufficio da accuse anonime e ne uscì prosciolto. Lasciò, tuttavia la Matrice, il 13 mar. ‘40, dopo 21 anni, trasferendosì ad Agrigento. Fu Direttore diocesano delle missioni in Curia, Canonico onorario della Cattedrale e parroco della Chiesa “M. SS. Assunta”, dal 12 dic. ’47, che abbellì e dotò nel ‘59 di asilo infantile e di laboratorio. Nella vita politica, da buon amico del Pres. on. Bonfiglio, suo alunno di liceo, avversò la sinistra fanfaniana, ch’era dal 1956 al vertice provinciale D.C., pubblicando a stampa la “Lettera aperta del can. Sorrento” (Agrigento 1958). Divulgò altre lettere, ciclostilate: “Quo vadis Moro, comite Fanfani?” nel 1962 contro l’apertura a sinistra e “Il bel cielo di Sorrento ecc…”, nel 1965 sul congresso DC nella predetta città, augurando che vi scendesse pure “il bello”, con il ritorno a don Sturzo e a De Gasperi. Nella notte tra il 18 e 19 Ott. 1966, l’arc. Sorrento fu colpito da infarto e ritornò alla Casa del Padre Celeste. Le sue spoglie giacciono nella cappella gentilizia del cimitero di Ravanusa. Lo ricordarono L’Amico del Popolo, dell’ott. ’77 con un art. dell’on. C. Mannino. Il clero e i fedeli delle parrocchie di Ravanusa con la solenne concelebrazione in memoriam del 19 mag.’81 in Matrice, e con i discorsi dei parroci Polisano e Carlino, dell’arc. Messana e del sig. V.Lauricella. Mons. Noto nel 1986 ne tracciò il profilo in “Ravanusa novecento anni di st. ecc..”. G. Cascina in “Ravanusa ieri” (Ravanusa 1989). G. Noto Termini in due articoli su “La Vedetta” marzo e aprile 1999. Lo scrivente, in una conferenza tenuta in Matrice nel nov. ’99, per iniziativa dell’arc. Catanzaro. D.De Gregorio, in “La Chiesa Agrigentina, Notizie Storiche” (vol. V., Agrigento 2000). Le città di Agrigento e di Ravanusa, grate gli dedicarono una via.
INEDITI SU ARCIPRETURA SORRENTO (1918 - 1940) - Nel 1920, quando la cooperativa del Partito Popolare assegnò ai contadini i lotti degli ex feudi Gibbesi e Drasi, due quote furono assegnate dall’arc. Sorrento ai Giovani di A.C. che volontariamente rinunciarono alla retribuzione per l’attività lavorativa svolta in quelle terre, a beneficio esclusivo della festa del S. Cuore. In compenso, quando tornavano dal lavoro erano invitati in casa dell’arciprete (C.so Garibaldi, immobile in atto posseduto dal dott. G. Pirrera), ove la madre, la za Cala preparava per loro la pasta a forno. Tali inviti si ripetevano spesso pure per gli altri collaboratori dell’arc., compresi i suonatori della Fanfara. Ai suddetti era riservata anche una botte del buon vino di lu zi Liddru, il papà dell’arciprete. Il quale, a buon diritto lamentava che il figlio arciprete gli prosciugava non solo le botti, ma anche le tasche con i lavori di chiesa, senza fine. Nel 1923 il Sorrento per l’eclatante sua attività antifascista fu perseguitato e minacciato di carcere dagli squadristi. E temendo l’arresto, a cui erano sottoposti i sovversivi, si nascose per un lungo periodo nel dammuso della casa di Salvatore Bellia, suo parente, in Via Lincoln. Nel 1928 per tutelare la chiesa a navata unica da interferenze e rumori esterni, il nostro arciprete fece costruire a corredo del portone d’ingresso un gigantesco paravento in legno massello a due ante e con due porte laterali, tuttora esistente. Ne affidò l’incarico all’artigiano Aronica Giuseppe Tito, uno degli ex adolescenti che nel Natale 1919, sfidando il dileggio degli anticlericali si accostarono alla S. Comunione. Nel 1935 il Nostro, a spese proprie e dei fedeli, restaurò il tetto della Matrice rinnovandone pure la capriata. Il nome dei carpentieri che vi lavorarono, ci è oggi noto, grazie all’architetto Guido Muratore che nel corso di altro restauro della chiesa. del decorso anno, diretto anche da lui, ha scoperto le iscrizioni riprodotte in foto. Ritengo doveroso ringrazialo pure per le tante foto donatemi, relative al prospetto della suddetta Matrice, che documentano la costruzione di essa da parte del barone Giacomo Bonanno con conci della polis di M. Saraceno. Si osservi, ad es. la foto del campanile, che evidenzia chiaramente il reimpiego di materiali edili.
20. ARC. ANGELO GRECO (1941-1941). Nacque a Palma Montechiaro il 10.05.1901 e fu ordinato Sacerdote il 20.07.1930. Dal 6 novembre 1933 fu nominato Vicario Curato nella Chiesa S. Erasmo di Naro, succursale della parrocchia “Maria SS. Annunziata” e ne prese possesso canonico il successivo 12 novembre 1933. La detta Chiesa fu eretta parrocchia con decreto vescovile del 21 novembre 1939 e il rev. D. Angelo Greco, unico Vicario curato, ne divenne il primo Parroco dalla medesima data menzionata. Benché piccola e semplice nelle sue linee architettoniche, la chiesa S. Erasmo, all’interno era adorna di artistici stucchi che facevano corona al simulacro della miracolosa “Madonna del Rito”, veneratavi da antico tempo. Resasi libera l’arcipretura di Ravanusa, il Vescovo Mons. Peruzzo il 24 marzo 1941 vi nominò D. Angelo Greco, che nello stesso predetto giorno ne prese possesso, restandovi, tuttavia, solo pochi mesi. Mons. Peruzzo, ben conoscendo il difficile ambiente di allora della nostra Matrice, si affrettò a conferire una nuova bolla al rev. D. Giuseppe Burgio, ritenuto di più valida tempra, appena questi ne fu disponibile e il rev. Greco malvolentieri dovette ritornare il 1° settembre 1941 alla precedente attività pastorale della “S. Erasmo” di Naro. Ivi, comunque, operò per un quarantennio, con instancabile apostolato, assai stimato dai fedeli, dai confratelli sacerdoti e dalla Curia. Grazie alle copiose offerte dei fedeli, acquistò le aree confinati con la predetta chiesa, che dotò di canonica e altri saloni per lo svolgimento delle attività parrocchiali. Coadiuvato sempre dalle due sorelle, fu dalle medesime assistito nelle infermità che lo afflissero negli ultimi tempi. Il primo gennaio 1980, per raggiunti limiti di età rassegnò le dimissioni da parroco. Poco dopo, il 27 aprile 1980, ritornava alla casa del Padre, lasciando nei parrocchiani tanto rimpianto.
21. ARC. CAN. MONS. GIUSEPPE BURGIO (1941-1955). Nacque a Ravanusa il 2 aprile 1911, figlio unico di Giovanni Burgio e di Calogera Nobile coniugati il 9 dicembre 1909, in Via Luigi Marino, 96. Il padre, lasciando la moglie e il figlioletto in tenera età, come tanti altri nostri concittadini in quegli anni, emigrò in cerca di fortuna in America, ove morì in data imprecisata. Il nostro futuro arciprete fu così accudito dalla mamma e dalle zie Carmelina e Maria Nobile coabitanti, che ogni mattina lo portavano con loro, sin da piccolo a messa in Matrice. Qui l’arc. Sorrento lo volle chierichetto e, scoprendogli la vocazione per il sacerdozio, lo avviò dai Redentoristi di Agrigento, presso cui frequentò il ginnasio. Nel Seminario di Caltanissetta il liceo e in quello di Agrigento il quadriennio di Teologia. Fu ordinato sacerdote il 20 aprile 1935 dal Vescovo Peruzzo e nominato Vicario Cooperatore dell’arc. Angelo Scrudato, nella Matrice di Canicattì. Essendo stato eletto Mons. Ficarra Vescovo di Pattì e resasi vacante la cattedra di S. Scrittura, Ebraico e Greco biblico da lui tenuta nel Seminario di Agrigento, al suo posto, il 12 ottobre 1936 vi fu nominato il nostro rev. Bugio, che ricoprì tale incarico sino al 1941. Dal 1936 al 1938, fu scelto dal Vescovo anche come Vice Rettore del seminario, in aiuto al Rettore Filippo Iacolino. Dal 1° febbraio 1940 al 10 settembre 1941 ebbe pure la bolla di parroco della Chiesa S. Giuseppe di Agrigento. E per la eccezionale nomea meritata in tale apostolato, Mons. Peruzzo gli assegnò una delle più difficili arcipreture, quella di Ravanusa, che gli aveva arrecato serie noie col S.Ufficio per le tante lettere anonime contro il precedente arciprete. Tali lettere erano, invero, opera di un solo ignobile grafomane, per come si venne a scoprire appresso. Il Vescovo, pur avendo emesso pochi mesi prima, bolla per detta Matrice a favore del rev. Greco, non esitò a revocarla. ò di persona. Le pratiche della elezione e presentazione presso la baronia Bonanno, che ne aveva diritto di Patronato, erano state già espletate dalla Curia e il nostro rev. Burgio poté così prenderne possesso, l’11 settembre 1941. Eravamo in pieno periodo bellico, stremati dal regime autarchico, dalla povertà galoppante per le braccia sottratte all’agricoltura dalle incessanti chiamate alle armi e dalla paura dei bombardamenti. Il nostro arciprete si prodigò con tutti i mezzi di sussistenza disponibili ad aiutare i bisognosi. Riaprì, nell’agosto ’42 l’Istituto delle Salesiane, i cui locali l’anno prima erano stati ipotecati dai Gallo, creditori della banca popolare del Sorrento, finita in dissesto. Le giovani casalinghe poterono riprendere la frequenza dei corsi di taglio, cucito e ricamo, e assicurare qualche soldo in più alle famiglie. L’occupazione militare alleata nel luglio ’43 distribuì viveri e vestiari e le condizioni di miseria della popolazione in parte migliorarono. Nel giugno 1944 altro aiuto venne dall’ECA (Ente Comunale Assistenza) e, nel successivo ottobre, dal Comitato Cittadino per la raccolta di fondi a favore dei disoccupati, costituito da autorità locali, tra cui il nostro arciprete, e rappresentanti del ceto abbiente. La POA (Pontificia Opera Assistenza), assai ricca di risorse nella nostra diocesi, fece il resto, sanando le altre piaghe delle famiglie. L’arc. Burgio ne curò il buon funzionamento, avviando grazie ad essa cantieri di lavoro per la manovalanza disoccupata e colonie elioterapiche per i ragazzi. Queste ultime funzionarono nell’immobile della Stazione ferroviaria, già utilizzato nella medesima attività dal fascismo e furono dirette dalle ins.ti Maria Sorrento e Pina Coniglio per le sezioni femminili e dall’ins. Luigi Musso per quelle maschili. Per diversi anni ne beneficiarono turni di una quarantina di fanciulli, tolti dai bivacchi delle strade, a tutto vantaggio della loro salute e formazione civica e religiosa. Nell’immediato dopoguerra erano sorte in aiuto dei lavoratori le cooperative rosse, che poi a fine ’45 occuparono l’ex feudo Conte Bosco, assegnandone quote a più di 350 famiglie contadine. Su sollecitazione del nostro arciprete, i dirigenti DC, nel suddetto anno, costituirono la cooperativa “S. Francesco” che suddivise ai 320 soci gli ex feudi acquistati Turchio, Suor Marchesa e Ficuzza. Con finanziamenti ottenuti dall’Assessorato Reg. e dal Ministero LL. PP., il Nostro completò gli stucchi del famoso Guglielmino, già deceduto, su tutta la navata della Chiesa affidandoli alla nuova ditta del figlio. Ristrutturò, altresì, la sacrestia, il salone per le attività parrocchiali e la canonica. Nel quartiere “Mastro Dominici” costruì, inoltre, una scuola materna privata, con refezione, giochi all’aperto e doposcuola per l’abbandonata infanzia del quartiere, che poté frequentarla gratuitamente. Affidò detta scuola alle Orsoline, da lui volute a Ravanusa, per le quali eresse a latere l’Istituto “S. Angela Merici”. Tra le prime collaboratrici figurano Giuseppa e Fifì Ministeri, Carmelina Pennica e Angelina Tricoli, quest’ultima morta, poi in fama di santità. Il nostro arciprete non solo sollevò i parrocchiani dalle loro precarie situazioni economiche, ma ne tutelò il credo evangelico. Avversò con intransigenza i partiti marxisti, marchiati di eresia dalla Chiesa e dall’adamantino Vescovo Peruzzo. Le loro turbolenti mobilitazioni, occupazioni di luoghi pubblici e comizi all’insegna di slogan anticlericali, destavano allora preoccupazione. Il blocco del popolo (PCI – PSI) nell’aprile ’46, a Ravanusa vinse le amministrative e per sottolineare il successo, issò le bandiere rosse dei due partiti sul campanile della Matrice, cui il Comune accedeva per la manutenzione dell’orologio. I giovani di AC e DC non tollerando l’offesa al luogo sacro, nottetempo le bruciarono. Di tale fatto, le sinistre incriminarono l’arc. Burgio, al cui carico venne spiccato un mandato d’arresto, ma i nostri giovani se ne addossarono la responsabilità, consegnandosi spontaneamente alle forze d’ordine. Detenuti ad Agrigento, dapprima in una caserma dei Carabinieri, e dopo in un camerone dell’Ospedale civile, a fine settimana (era quella Santa) per la mediazione di Mons. Peruzzo, che riuscì a chiudere la vertenza, tornarono in libertà. I giovani e donne di A.C. in Matrice, animati dal nostro arciprete, coordinavano in gruppi tutte le attività parrocchiali, divenendo anche agguerriti paladini della Comunità ecclesiale. Uno di quei giovani, Gaetano Cavalcanti, per eliminare il disturbo arrecato alle funzioni religiose, dai comizi delle Sinistre in piazza Matrice, non esitò a suonare motu proprio e più volte a distesa le campane, sciogliendo le provocatorie adunanze. E in strada e in piazza il gruppo giovanile faceva sempre corona all’arciprete, a scudo di qualche insulto, accompagnandolo a tarda sera sino a casa. Ove si eccettuino tali scaramucce alla Guareschi, l’arc. Burgio cristianamente era irreprensibile. Amava benevolmente tutti, anche i sinistrorsi. Le sue affettuosità erano genuine. Il suo sorriso sincero. Redarguiva amorosamente il peccatore e incoraggiava chi mostrava buona volontà. Nelle elezioni del maggio ’47, per l’inavvedutezza delle sinistre che si presentarono con liste separate, la DC conquistò la maggioranza, anticipando la vittoria in campo nazionale del 18 aprile ’48. Le sinistre divennero furibonde e accusarono l’arciprete come principale autore della loro disfatta. Il Vescovo, assai prudente, lo allontanò per un anno da quell’ambiente ostico, affidandogli la guida della Peregrinatio Mariae in diocesi. Qui l’arc. Burgio palesò pure il suo grande carisma. Con la Madonna Pellegrina, la diocesi intera fu risvegliata da una eccezionale ondata di fede, mai prima riscontrata. In sua assenza, i giovani d’A.C. continuarono a tenere banco. Il nostro arciprete, a Ravanusa aveva pure costituito i Comitati Civici, presieduti dall’ univ. Lillo Ninotta, collaborato da alcune Zelatrici. Per l’elevata cultura politica ed il talento oratorio, Lillo dopo aver operato con successo anche in altri Comuni, nel 56 ne divenne presidente provinciale assai stimato. Nel ’48, gli aiuti economici statunitensi del Piano Marshal avviarono nel paese la ricostruzione postbellica. Si ristabilì, altresì, l’ordinamento democratico. Cessate, però, le vecchie urgenze, si decadde nel clientelismo. E peggio. Nella nostra città, l’amministrazione DC perdurò sino al 52, ma senza grandi obiettivi ed innovazioni, adducendo a peregrina scusa l’ostruzionismo delle sinistre. Nel 1952, il nostro arciprete organizzò una sezione ACLI in un ampio locale dell’ex Corso Vittorio Emanuele, diretta da Lillo Pitrola e dallo scrivente allora universitari, per l’assistenza dei lavoratori e il disbrigo delle loro pratiche contrattuali, infortunistiche e previdenziali. Nel 1954, per il centenario del dogma dell’Immacolata, l’arc. Burgio collocò due campane, nel campanile della Matrice, dedicandone una al S.Cuore di Maria e l’altra al S. Cuore di Gesù. Nella notte tra il 4 e il 5 febbraio del ’55, accadde l’inaudito. Ad opera di sacrileghi ignoti, venne violato il tabernacolo della Chiesa Madre, la pisside spezzata, le sacre particole seminate sull’altare e in sacristia appiccato il fuoco. Nell’incendio si rovinarono quadri, paramenti, vasi sacri e bruciarono tutti i registri e i documenti della parrocchia. Crollarono trecento anni di storia, ora difficilmente ricostruibile. Il disegno della mente criminale sortì l‘effetto voluto. L’arc. Burgio, per ragioni prudenziali venne trasferito. Nell’Ottobre ‘55 il Vescovo Peruzzo lo nominò Professore di Morale nel Seminario di Agrigento e successivamente pure Canonico penitenziere della Cattedrale. Ad Agrigento il Nostro continuò, senza scomporsi, il suo fervido apostolato anche nelle missioni in Africa. Ad Ismani in Tanzania, nel 1972 aprì una parrocchia, gestita da sacerdoti e con fondi ed offerte della nostra diocesi. I prescelti furono D.Catanzaro, divenuto poi arciprete a Ravanusa, e D. Taffari, ambedue di Menfi. Nel 1980 al nostro ex arciprete la S. Sede conferì la nomina di Protonotario apostolico e la Diocesi agrigentina la Targa S. Gerlando per il suo apostolato a pro delle anime, anche in terra africana. Quello stesso anno, Mons. Burgio cominciò ad accusare dolori ai polmoni e dopo vari ricoveri a Palermo e a Roma, mentre si trovava a Chianciano, per la cura del fegato, causa un collasso finì nell’Ospedale Civile di Arezzo. Qui, malgrado tutte le cure il 14.7.1982, lo colse sorella morte e tornò, ricco di meriti e di speranzosa fede, alla casa del Padre. Ora le sue spoglie riposano nella cappella gentilizia di famiglia a Ravanusa, ove la gigantesca figura di questo santo e battagliero arciprete, difficilmente sarà obliata.
22. ARC. CAN. MONS. GIUSEPPE TRAINA (1956 - 1965). Nacque a S.Giovanni Gemini (AG) il 15 giugno 1927, terzogenito di nove figli (tra cui Salvatore divenuto pure sacerdote) da Calogero Traina e da Maria Angela Fulco. Nell’ottobre 1941, fu avviato con enormi sacrifici economici dei famigliari nel Seminario vescovile di Agrigento, ove si distinse per impegno negli studi, zelo e pietà cristiana. Sin da allora accusava problemi di salute e l’infermiere del Seminario chierico G. Policardi l’ebbe tra i più assidui clienti di punture per cure ricostituenti. Ordinato sacerdote il 6 luglio 1952, nella Chiesa Madre della natia S. G. Gemini, dal Vescovo ausiliare Mons. Vincenzo M. Jacono, luminare di S.Scrittura, fu dal medesimo scelto come segretario per un biennio. Pur non avendo completato il corso di teologia, dal Vesovo Mons. Peruzzo, dal 01.10.1951 al 30.09.1953, ebbe l’incarico di docente di lettere nella Scuola Media e collaboratore del Seminario minore di Favara. Dal 01.10.1953 al 30.09.1955 fu nominato professore di Lettere e Storia delle Religioni nel Seminario maggiore di Agrigento. Dal 1953 al 1955 fu anche Assistente diocesano della FUCI agrigentina. Dal 1° ottobre 1955 al 30.04.1956 fu “Delegato Vescovile” per l’Arcipretura “S.Giacomo” di Ravanusa, nelle more che l’arc. Burgio tentennante a lasciare la Matrice, desse il suo benestare all’emissione della bolla definitiva. La quale fu siglata da Mons. Peruzzo il 01.06.1956, a seguito anche dell’ elezione e presentazione presso gli eredi dei baroni Bonanno, ancora detentori del diritto di Patronato, La Chiesa Madre di Ravanusa fu la prima palestra del suo ministero parrocchiale, svolto con modestia e umiltà, ma pure con elevata cultura e rigore etico religioso. Lo collaborarono i Vicari Cooperatori, Don Vincenzo Libertella per un anno, divenuto cappellano militare e in seguito perìto in un incidente stradale, e dal giugno 1961 al febbraio 1963 Don Giuseppe Sciandrone. Nacque così il primo gruppo di Scout a Ravanusa, la FUCI con ben trenta universitari e si incrementò la GIAC. L’arc. Don Traina fu il prescelto Confessore e Padre spirituale delle Zelatrici e delle Orsoline. Nell’istituto S. Angela Merici allocò scuole materne, doposcuola, refezione, ed elementari autorizzate, in seguito surrogate dalle statali, per .curare meglio l’istruzione religiosa dei bambini del rione povero e depresso di “Mastro Dominici”. In Matrice seguì con attenzione le lezioni di catechismo per i piccoli, e l’oratorio parrocchiale per i più grandicelli. Nella formazione religiosa delle ragazze, fu coadiuvato dalle Suore Salesiane con i corsi di taglio, cucito, ricamo, musica, recite, accademie e attività teatrali. Don Traina s’adoperò pure per il restauro edilizio della Chiesa. Sostituì gli antichi altari in pregiato legno laccato e dorato malandati, con moderni altari stilizzati in marmo, salvandone, però, dal macero uno, allora in buono stato di conservazione, che pose nel salone attiguo alla chiesa. Ebbe il torto di sostituire il meraviglioso fonte battesimale marmoreo del 1666 del Serpetro, che seppellì nella sottostante cripta, con uno molto più piccolo e dozzinale da lui collocato nel presbiterio. Schivo e riservato con i politici, mai li esaltò né si fece strumentalizzare. Le battaglie del ’48, con la caduta del muro di Berlino, apparivano non più necessarie alla tutela dei diritti della Chiesa, difesa daAggregazioni laiche e Partiti, che già accusavano lacerazioni correntizie, non sanate dal medesimo Cencelli. Per le proprie cattive condizioni di salute, dopo la morte dell’arc. Antonino Sansone a S. Giovanni Gemini, preferì rientrare presso i suoi famigliari onde essere meglio assistito. Il 31 dicembre 1964 lasciò Ravanusa e il primo gennaio 1965, avuta la nomina dal Vescovo Petralia di Parroco-Arciprete nella sua città natale, ne prese possesso canonico. Lì, ristabilitosi, operò con nuovo vigore per sedici anni, sino al 30.06.1981, ristrutturando la chiesa., rifacendo un nuovo pavimento e nuovi arredi, costruendovi la Casa Canonica e un Centro Giovanile. Pubblicò anche un giornalino parrocchiale e nel settembre 1976 con “Radio Gemini Centrale”, diffuse la voce della comunità parrocchiale. Ritenendo, poi, il ministero pastorale più proficuo con l’alternanza di nuove energie presentò al Vescovo Bommarito le proprie dimissioni, irrevocabili. Il Vescovo che ben conosceva i suoi talenti, lo volle vicino a sé, nominandolo dal giugno 1981 Cancelliere della Curia vescovile e appresso Vicario Episcopale per i Laici e i Mass-Media. Nel settembre 1986 lo fece insignire della commenda di Cappellano di Sua Santità con diritto al titolo onorifico di Monsignore. Lo nominò, altresì, Direttore di Radio e Tele “Concordia”, Delegato Vescovile di Tele Pace e TR 98 e nell’Ottobre 1994, Direttore dell’Archivio storico della Curia Vescovile di Agrigento, ultima sua fatica. Si attivò per informatizzarlo. Agli arcipreti di tutti i Comuni della Diocesi inviò gli elenchi del clero dei rispettivi paesi, risultanti dai vari atti dell’Ufficio diocesano e dalle relazioni delle Visite pastorali, richiedendone il controllo e l’aggiornamento. Per la nostra città, invitato dall’arc. Don Catanzaro, verificai e corressi date, nominativi e duplicati dei sacerdoti ravanusani, sull’elenco ricevuto, aggiungendovene molti altri, reperiti dai nostri rogiti e riveli. Mi telefonò gentilmente, per ringraziarmi, sorpreso dal cospicuo elenco da me inviato e mi accennò al suo cattivo stato di salute, rammaricato solo perchè non gli consentiva di lavorare in archivio più di due giorni alla settimana. Nel 1995, a S. Giovanni Gemini fu Vicario Cooperatore del fratello don Salvatore nella parrocchia BVM di Fatima. Nel maggio 2000 fu pure rettore della Chiesa Madonna del Carmelo nella stessa città. A seguito di un rischioso intervento chirurgico per un tumore in fase avanzata, dalla terapia intensiva passava in coma, e il 5 dicembre 2000 tornava alla Casa del Padre, munito in tempo utile di tutti i conforti religiosi. Nel testamento spirituale del 25. 01.1997, da buon ministro di Dio ci ha donato un messaggio di viva fede, ringraziando la SS. Trinità per averlo creato, fatto cristiano e Sacerdote, la sua famiglia per il bene grande datogli negli affetti umani e nella fede cristiana, e la Chiesa per la fiducia accordatagli con le responsabilità che lo hanno arricchito di infinite grazie. Ha avuto un pensiero anche per noi, aggiungendovi: “Ringrazio anche le persone che ho incontrato nei miei lunghi anni di ministero sacerdotale, in particolare a Ravanusa e a S. Giovanni Gemini e ad Agrigento. Domando a tutti perdono per le mie mancanze, domando a Dio perdono per i miei peccati. La mia vita, offerta per la gloria di Dio e il bene dei fratelli, adesso la depongo nelle mani di Dio. Sac. Giuseppe Traina”.
23. ARC. DON FILIPPO MESSANA. Don Messana, nato a Ravanusa, il 28.1.1929, da Domenico Messana e da Vita Zagarrio, fu ordinato sacerdote da Mons. G. B. Peruzzo nella Cattedrale di Agrigento il 29 giugno 1952, festività di S. Pietro e Paolo. La sua prima missione pastorale la svolse dall’1.11.1952 al 31.3.1954, come Vicario Cooperatore dell’Arc. Don Giuseppe Cuffaro nella Matrice “Spirito Santo” di Cattolica Eraclea, acquisendo dal suddetto spirito di iniziativa, profonda fede cristiana ed entusiasmo. Dal 1°.4.1954 al 6.1. 1959 fu parroco alla “B.M.V. Vergine del Carmelo” di S. Stefano Quisquina e Delegato vescovile di AC dell’omonima zona. Dal 5.1.1959 al 31.1.1965 Parroco Arciprete al SS. Salvatore di Calastra e per oltre un trentennio, dal 1° febbraio 1965 al 28 settembre 1996, è stato Parroco Arciprete della Chiesa Madre “S. Giacomo” di Ravanusa, ove ha operato laboriosamente e con dignità sacerdotale. E’ stato tra i primi a rinunciare alla prassi del tariffario allora vigente, con versamenti bancari, per i battesimi, matrimoni e riti funebri, accettando soltanto libere e volontarie offerte e dispensando anche da queste i fedeli indigenti. Nella nostra Matrice, l’arc. Messana ha curato particolarmente l’Azione Cattolica nei settori Uomini, Donne, Gioventù Femminile e Aspiranti, e le Associazioni Apostolato della Preghiera, O.V.E. e Figlie di Maria. Ha istituito, altresì, un numeroso gruppo A.I.M.C. Il 20.2.1982, nella ricorrenza del 350° anniversario dell’arcipretura, sorta con bolla 20 febbraio 1632 del vescovo Traina, ha officiato una solenne concelebrazione, presenti il Vescovo Bommarito, l’Arcivescovo Lauricella e quasi tutti i sacerdoti di Ravanusa, provenienti anche da altra sede. Nel successivo Settembre ha, quindi, guidato un pellegrinaggio di parrocchiani a santuari mariani, ricevuti anche in pubblica udienza l’otto settembre, a piazza S. Pietro dal papa Giovanni Paolo II., che rivolse “ai fedeli, concittadini ed emigrati di Ravanusa, nel 350° della loro parrocchia un particolare saluto e l’apostolica benedizione”. Nel 1983 su suggerimento dell’Arcivescovo Mons. Lauricella, considerata la crisi invero nazionale dell’A.C., Don Messana fondò a Ravanusa la prima comunità neocatecumenale, svolgendovi assiduamente le funzioni di Presbitero. Oggi tale comunità conta cinque aggregazioni con più di cento iscritti, di cui molti per resa testimonianza salvati dai mali dell’odierna società. Una decina di detti neocatecumeni, nel periodo della sua arcipretura, ha partecipato ai pellegrinaggi delle Giornate Mondiali della Gioventù, incontrando il Papa a Czestochowa (1991), a Denver (1993) e a Loreto (1995). All’attività pastorale il nostro arciprete ha aggiunto le premure per l’edilizia e il rinnovo degli arredi sacri. L’8 maggio del 1967 collocò nel campanile a sinistra una quarta campana di 220 chili, la cui dedica a “Maria Madre della Chiesa e Regina del Mondo” fu dettata da Mons. Noto. Nel 1969 con finanziamento regionale disposto dall’On. Bonfiglio, rifece il pavimento in marmo della chiesa e dei locali annessi. Recuperò lo storico fonte battesimale del. Serpetro, abbandonato dall’arc. Traina sotto il pavimento della chiesa, e fattolo restaurare lo riutilizzò, collocandolo nel presbiterio. Quello prima in uso, più piccolo in marmo bianco di Carrara, poi, lo donò a don Pino Giuliana per la chiesa dell’Oasi di Riesi. Don Messana ristrutturò la canonica, ricavandone pure un monolocale per le attività neocatecumenali e di catechesi, e ne rinnovò le travi, i soffitti e le finestre. Ricostruì le scale di accesso ai campanili; collocò all’interno della chiesa sopra il cornicione una inferriata di protezione e rifece le otto finestre, malridotte dal tempo, in alluminio anodizzato e vetri retinati. Sostituì i vecchi banchi e il confessionale, con altri in massello noce e le sedie con le nuove tipo svedese. Rinnovò, altresì, l‘impianto elettrico e di amplificazione e acquistò un efficiente Organo elettrico con box. Abbellì la chiesa con tre quadroni del pittore galatino Francesco Alberghina, “La vocazione di S.Giacomo e Giovanni” (1982), “Il Banchetto eucaristico” (1982) e “Maria Madre della Chiesa” (1983). Fece restaurare l’Urna del Cristo; ne sostituì i vetri con altri plastificati e acquistò un’Urna più leggera per la processione del Venerdì Santo. Rinnovò la Via Crucis con i quindici quadri su pannello in ontano scolpiti a bassorilievo dall’artista Emma di S. Cataldo. Curò, inoltre, incoraggiato e collaborato dalle generose offerte dell’arcivescovo Mons. Lauricella, il rivestimento degli spogli stucchi bianchi dei Guglielmini, con la costosissima doratura a foglioline oro 24 K. Nel prospetto della chiesa sopra la nicchia, durante la sua arcipretura, è stata collocata la vetrata artistica della Trasfigurazione di Gesù con gli apostoli Pietro, Giacomo e Giovanni, dono di Mons. Angelo Noto. L’arc. Don Filippo Messana, ha festeggiato il 50° dell’ordinazione sacerdotale il 29 giugno 2002. Gli sono stati vicini i fedeli, i famigliari e le ben amate comunità neocatecumenali, sorte a Ravanusa per sua iniziativa.
24. ARC. DON SAVERIO CATANZARO. Nato a Menfi (AG) il 7 marzo 1936 da Antonino e da Barbera Paola, fu ordinato presbitero da Mons. G. B. Peruzzo, il 21.5.1961 nella Cattedrale di Agrigento. Dall’1. 9.1961 al 30.9 1962 ebbe l’incarico di Vicario Cooperatore del “SS. Crocifisso” di Aragona, e dall’1.10.1962 al 6.11.1965 del “SS. Rosario” di S. Margherita Belice. Fu, quindi, Parroco a S. Agostino di Caltabellotta dal 7.11.1965 al 31.10.1972. Scelto insieme a Don Saverio Taffari, dal Vescovo Mons. Petralia per costituire una missione in Tanzania, dipendente dalla diocesi agrigentina, voluta dal nostro Mons. Burgio, accettò di buon grado la nomina di Parroco Missionario di Ismani, nella lontana diocesi di Iringa, ove prese possesso il 4.11.1972, permanendovi un decennio sino al Settembre 1982. In Africa, coadiuvato dalle suore Teresine, lavorò con fede di apostolo. Sfidando il torrido e nefasto clima e le diffuse malattie tropicali, curò pure l’assistenza sanitaria delle fasce più diseredate della popolazione. Imparò la difficile lingua di quel territorio e riuscì a reperire in loco diverse vocazioni di aspiranti sacerdoti e suore. Ne ottenne un meritato riconoscimento con la nomina, nel 1976, di Canonico onorario del Capitolo della Cattedrale di Agrigento. Rientrato nella nostra diocesi, il primo dicembre del 1982 fu nominato Parroco Arciprete del SS. Rosario a S. Margherita Belice, permanendovi sino al 31 agosto 1996. In tal periodo fu, altresì, Delegato Vescovile della Commissione Diocesana “Pro Parrocchia Ismani”, Vicario Foraneo del Vicariato n. 13 che comprendeva i Comuni di Menfi, Montevago, Sambuca, S. Margherita Belice, e Componente dei Consigli Diocesani Presbiterale e Pastorale. Dal primo settembre 1996, alfine, fu nostro Parroco Arciprete della Matrice S. Giacomo. Conquistò presto la stima e l’amicizia di tutta la città, per il suo dinamismo e per le tante iniziative a sostegno dei giovani, degli immigrati, poveri, disoccupati e drogati. Che ebbero da lui parole di conforto e aiuti concreti, elargiti generosamente di tasca propria e dalle istituzioni parrocchiali. Da buon samaritano soccorse più volte e salvò drogati “strafatti”, in overdose, in stato di abbandono a terra negli angoli bui di strade e cortili, trasportandoli nelle loro abitazioni e tenendoli vicini a sé. Nell’amministrare i sacramenti, mai accettò pagamenti da prontuari, utilizzando le libere offerte pervenutegli, solo per le spese di culto, affidate al Cassiere del Consiglio pastorale. In quegli anni vedemmo tanta gente che mai aveva frequentato chiesa venire in parrocchia, partecipare alle funzioni sacre e collaborarlo, seguendolo persino nei suoi viaggi annuali in Tanzania. Nelle processioni del Venerdì Santo portarono la Vara dell’Addolorata un folto gruppo di ragazze in abitino viola delle ex confraternite e l’Urna del Cristo, i Soci di un Circolo di compagnia in abitino rosso. L’Azione Cattolica, che anche in campo nazionale pareva eclissata, nella nostra Matrice ha avuto un grande risveglio, la Caritas è stata attivata e fiore all’occhiello rimane l’ARRDES per il recupero e reinserimento dei disagiati ed emarginati sociali, alcolisti e drogati. Don Saverio ha avuto, inoltre, particolare attenzione, con la sua assidua assistenza spirituale alla comunità neocatecumenale, che partecipò con un discreto numero di giovani iscritti alle Giornate Mondiali della Gioventù, incontrando il Papa G. Paolo II a Parigi (19-24 Agosto 1997) e a Tor Vergata (Roma 15-20 Agosto 2000). Don Saverio si è interessato pure alla ristrutturazione, con un “cantiere scuola” della Canonica e dei saloni attigui alla Chiesa per l’accoglienza delle aggregazioni laicali. Durante tali lavori, reperì in un ripostiglio otto tele sacre. Alcune erano del Manzelli e altre di autore ignoto. Ne diede notizia alla Soprintendenza BB.CC.AA. e costituì un gruppo giovanile di lavoro, denominato “Ab Urbe Condita”. I quadri vennero ripuliti, restaurati sommariamente ed esposti in una Mostra d’arte sacra, a cui diedi tutta la mia collaborazione. Nella mostra furono esposte anche un’antica e artistica stola in oro zecchino, ereditata da Don Saverio e una serie di grandi foto degli affreschi e tele del Santuario M. SS. Assunta, riprese dal predetto gruppo giovani. Nel gennaio 1997 il Nostro ha avuto la nomina di Vicario episcopale della Zona P. Gioacchino La Lomia e di Componente del Consiglio Episcopale Diocesano. Il 7 gennaio 2002, resasi libera l’arcipretura della sua città natia, con nostro grave rammarico, e pare anche col suo, ha lasciato la nostra Matrice S. Giacomo per prendere possesso canonico nel giorno successivo come Parroco–Arciprete della Chiesa Madre “S. Antonio di Padova” di Menfi. La nostra Ravanusa, però, gli è rimasta nel cuore e spesso vi ritorna, pur se fugacemente, per riabbracciare tanti e tanti ex parrocchiani, come lo scrivente, e per trascinarne ancora qualche altro in Tanzania, ove nella pausa estiva si reca ogni anno.
25. L’ARCIPRETE DON EMANUELE CASOLA Don Antonino Emanuele Casola di Emanuele e di Piazza Nunzia è nato a Cattolica Eraclea il 10.2.1956 ed è stato ordinato Presbitero dal Vescovo Mons. L. Bommarito il 7.12.1981 nella Chiesa Madre di Cattolica Eraclea. Non ancora sacerdote, dal 24.4.1981 ha ricoperto a Ribera l’incarico di Consulente Ecclesiastico dei Coltivatori Diretti e, dal 1°.8.1982 al 30.06.1988, di Cappellano dell’Ospedale Civile. Nella predetta città è stato, altresì, dall’1.10.1984 al 13.1.2002, Parroco di S. Domenico Savio stimato e ben voluto da tutti. In detto periodo fu, pure, Componente del Consiglio Pastorale Diocesano dal 20.3.1986 al 15.6.1990 e dal 27 Luglio 1994 Responsabile della Formazione Permanente dei Presbiteri. Il 14 gennaio 2002 ebbe conferita la nomina di Parroco Arciprete della Matrice S. Giacomo di Ravanusa. Il successivo 9 febbraio ne prese possesso canonico e continua a tutt’oggi ad esplicarvi un eccellente apostolato al servizio del Signore e della Chiesa. Qui, Don Casola ha portato una folata di spiritualità, predicando reiteratamente “Vi voglio tutti santi”, “Dobbiamo essere tutti santi”, e, altresì un marcato dinamismo, nel sollecitare la risoluzione delle problematiche sociali. Da buon maestro non ha atteso interventi dall’alto o da altri, bensì ha portato la propria pietruzza e quella della parrocchia alla costruzione della “maramma”. Si è interessato alla povertà, disoccupazione, immigrati, mafia, acqua, droga, alcolismo, globalizzazione, handicap, aborto, assillanti piaghe del nostro paese, elevando pure la formazione culturale e religiosa dei ravanusani con l’intervento di istituzioni e di note personalità ecclesiali e laiche: Comunità delle Beatitudini, Medici senza Frontiere, Suore Francescane, Collegine, Apostole della Parola, P. Alex Zanotelli, P. Matthias, Don Emma, Don S. Casà, Ernesto Oliviero, Rita Borsellino ed altri. Ha diffuso, peraltro, la Parola del Signore capillarmente nei cortili, strade, piazze, abitazioni degli ammalati, siti archeologici, ex miniere e contrade varie del paese, che ha trasformato in luoghi sacri di preghiera corale e di celebrazione del mistero eucaristico. Tra le sue prime iniziative va segnalata la istituzione dell’«Oratorio S.Giacomo» nei pomeriggi dei giovedì e domeniche, e del «Doposcuola» nei pomeriggi dal lunedì al venerdì riservato ai bambini con difficoltà socio-scolastiche, affidati a personale specializzato volontario, utilizzando la palestra e i locali dell’ex Istituto Salesiano. Nel 2003, altresì, la fondazione del «Gruppo Famiglia» e del «Gruppo Giovani» avviati in un cammino formativo e spirituale comunitario. L’arc. Casola ha anche avuto a cuore la tutela dell’edificio sacro. Su progetto dell’ing. F. Lazzaro e dell’arch. G. Muratore, finanziato dall’Ass. Reg. LL.PP., dall’ottobre 2004 al giugno 2005 sono stati effettuati i lavori di manutenzione straordinaria della chiesa e del restauro conservativo del suo prospetto. E su progetto dell’Ing. G. Musso in ordine all’abbattimento delle barriere architettoniche, è stato realizzato un decoroso accesso degli invalidi alla chiesa. Il culto del S. Cuore di Gesù è stato, altresì, curato con grande impegno, celebrandone tutti gli anni in grande la festività liturgica, la seconda domenica di Settembre, senza ricorso a contributi finanziari del Comune. Nelle relative programmazioni, il notro arc. ha previsto, mostre di pittura religiosa, “fraternità nei cortili”, incontri con la comunità rumena, sit-in per problemi locali, giorno di digiuno, Santo Rosario, Via Crucis per le strade, Madonnari, cenacoli nei quartieri, veglia in chiesa e adorazione del Santissimo, S. Messa, Vespri solenni, banda cittadina, Processione per la strada dei Santi, fuochi d’artificio e concerti musicali. Nel Giugno 2005, è stata pure restaurata la meravigliosa statua lignea del S. Cuore, dono del popolo ravanusano per l’Anno Santo 1900, dall’arch. Aldo Vassallo di Palma M. a spese del Lions Club Ravanusa e Campobello di Licata. L’arc. Casola, inoltre è stato il primo ad avviare, dal luglio 2002, il culto di S. Giacomo Patrono della nostra Chiesa Madre, dedicatagli nel 1632 dal barone Giacomo Bonanno, che nel passato ebbe soltanto le fugaci attenzioni dell’arc. Lentini con il quadrone “Vocazione di S. Giacomo” del 1771 di Provenzani e dell’arc. Messana con l’altro del 1982 del galatino Alberghina. Nei giorni precedenti la festività liturgica Don Casola ha guidato un pellegrinaggio parrocchiale alla Chiesa S. Calogero di Naro, antica sede dell’hospitale S. Giacomo de Altopassu, e il 25 luglio ha portato in processione solenne il quadro di S. Giacomo. Il giorno dopo, per la festività di S. Gioacchino e S.Anna, in Piazza XXV Aprile ha dato il via alla I^ edizione della Festa dei Nonni, con un riuscitissimo recital. Nel settembre ha inaugurato, nel presbiterio della Chiesa Madre, la statua in marmo di S. Giacomo della Ditta Felici di Massa Carrara, su disegno di Angelo Rago, che ha collocato nella nicchia del prospetto della suddetta, vacante sin dai primi anni della sua costruzione. Ne ha, altresì ornato la parete sinistra con un quadrone di Giandalia, dono di un fedele, dedicato alla “Vocazione di S. Giacomo” e ha impreziosito il grandioso paravento in pino pece dell’ingresso con una artistica luminosa vetrata ad intarsio, attinente la vita del predetto santo Patrono. Negli anni appresso, il nostro arc. Casola per la festività di S. Giacomo, ha programmato visite alle zolfare di Trabia-Tallarita e Muculufa, “fraternità nei cortili”, “momenti di preghiera” guidati dagli Arcivescovi pro-tempore Bommarito, Ferraro e Montenegro, fiaccolate animate per il “Centro Amico”, per il museo archeologico e la casa degli anziani, incontri con i politici e con gli emigrati, pellegrinaggi e visite a santuari di Avola, Gibilmanna, Valverde, S. G. La Punta, Camaro, Lourdes, Fatima, Santiago di Compostella. Dal 28 Febbraio al 14 Marzo 2004, il Nostro ha promosso la Missione Cittadina dei Padri Passionisti, con Catechesi e Incontri con i giovani, visite dei missionari e delle suore alle scuole, alle famiglie, agli ammalati nelle singole parrocchie e Celebrazione Penitenziale, Eucaristica, presente l’Arciv. Ferraro. Nelle attività parrocchiali, inoltre, ha tenuto sempre a sé vicini i più poveri e derelitti e ha saputo dare impulso alle aggregazioni ecclesiali laicali: “A.C”., “Caritas”, “CAV”., “ARDES”, “Ex Allieve delle Figlie di M. Ausiliatrice”, “Grest estivo” per i ragazzi, “Ist. Orsoline”, di cui peraltro è Assistente Spirituale nella Casa Madre di Canicattì (da segnalare i pellegrinaggi da lui curati alla tomba di Angelina Tricoli morta in fama di santità), e “Comunità Neocatecumenali”, che sono divenute cinque con oltre un centinaio di iscritti. Una buona rappresentanza di essi, ha partecipato al pellegrinaggio di dieci giorni, dal 25 Luglio al 3 agosto 2002, per la “XVI Giornata Mondiale della Gioventù” a Toronto, incontrando il Papa G. Paolo II a Downsview in Canada e Kiko Argüello, loro fondatore a Midland (USA). E’ stata, altresì, presente alla “XX GMG” di Colonia, dal 16 al 21 Agosto 2005, e alla “XXIII GMG” a Sidney dal 15 al 20 Luglio 2008, nelle quali ha incontrato Papa Benedetto XVI. Ritengo doveroso menzionare la visita pastorale in Matrice dell’Arcivescovo Mons. Ferraro, effettuata dal 14 al 17 aprile 2007, che è stata un’ottima occasione di crescita spirituale dell’intera comunità ravanusana. Accolto all’ingresso del paese da un folto gruppo di bambini in bicicletta, e dall’arciprete e fedeli in Piazza XXV Aprile, l’Arcivescovo ha familiarizzato con il Consiglio pastorale, visitato le scuole, gli ammalati, le autorità comunali, i militari della locale Caserma dei Carabinieri. Si è intrattenuto, poi, con i ragazzi del catechismo, i giovani, i papà e le mamme, meditando con le suddette la Bibbia in chiesa e concludendo con la recita del S. Rosario e la celebrazione solenne della S. Messa. Il nostro arciprete negli incontri di preghiera dei Lunedì estivi nei diversi quartieri, ha altresì, preparato i fedeli alla celebrazione dell’anno paolino 2008, svolgendo la tematica “S. Paolo apostolo delle Genti”, con interventi propri e di altri qualificati relatori, cui sono seguiti canti animati dei vari gruppi parrocchiali. Resta da dire che noi parrocchiani, grati per l’apostolato svolto nella nostra città dall’arc. Casola, con impegno, elevata cultura e apertura al sociale. preghiamo il Signore di conservarcelo a lungo. Don Casola vive la Parola di Dio e la Povertà evangelica e spende la sua vita sacerdotale per la santità di tutta la nostra Comunità ecclesiale. GLI ARCIVESCOVI MONS. FERRARO E MONS. MONTENEGRO A RAVANUSA
CARMELO FERRARO (1988-2008). Vescovo di Patti dal 30 marzo 1978, venne assegnato alla sede di Agrigento il 3 novembre 1988. Nella nostra diocesi ha portato un nuovo soffio di spiritualità, non disgiunta da un costante impegno per la soluzione delle problematiche sociali. Pastore insonne e vigile, il 9 maggio 1993 ci ha donato la visita di Papa Giovanni Paolo II, il cui grido, contro la mafia caina, accanto alla “grande Croce che è stata piantata nella pianura sotto i templi…, risuona ancora nella Valle agrigentina e nel mondo intero (Mons. Lucio Li Gregni). Il medesimo Santo Padre, il 2 dicembre 2000 gli ha conferito la nomina di Arcivescovo Metropolita delle sedi suffraganee di Caltanissetta e Piazza Armerina. La visita pastorale Di Mons. Ferraro a S. Famiglia è stata occasione meravigliosa di crescita cristiana di quella vasta comunità parrocchiale. Un’analoga crescita è avvenuta nella successiva sua visita in Matrice, grazie pure alla fervida fase preparatoria a cura del Consiglio parrocchiale e delle Aggregazioni ecclesiali laicali, saggiamente guidati dal nostro Arc. Don Casola.
FRANCESCO MONTENEGRO (2008 e continua). Nativo di Messina, è stato ordinato sacerdote l’8 agosto 1988 nelle suddetta città. Dal 1971 al 1988 fu segretario particolare dagli Arcivescovi Fasola e Cannavò. Dal 1988 al 1998 parroco di S. Clemente di Messina e Direttore regionale della Caritas. Dal 1998 Prelato d’Onore di S. Santità e Canonico della Cattedrale. Il 18 marzo 2000 fu nominato ausiliare dell’Arcidiocesi di Messina, Lipari e S. Lucia del Mela e il 29 aprile del suddetto anno consacrato vescovo. Il 25 febbraio 2008 Arcivescovo Metropolitano di Agrigento e nel successivo mese di maggio Presidente della Caritas italiana. Attivissimo segue da vicino la vita pastorale dei sacerdoti, parroci e fedeli dell’Arcidiocesi, rinunziando con umiltà a pompe e cerimoniali di spettanza. Più volte è stato gradito ospite della Matrice di Ravanusa, in occasione del funerale al rev. D. Savarino e degli incontri del Lunedì nei cortili istituiti dall’arc. Casola, ove ha preferito sedere accanto agli altri come un comune fedele S O L F A T A R I E C O M M E R C I A N T I D I Z O L F O I. In ordine agli antichi mestieri, un cenno particolare meritano i solfatari e i commercianti di zolfo, coevi come i burgisi alla stessa fondazione, nel seicento, della “terra” di Ravanusa. Miniere di zolfo nell’agrigentino ve ne furono almeno sin dal secondo secolo d.C. Diverse tegulae sulphuris di quell’epoca, con il marchio dell’officina produttrice, sono ora al Museo Archeologico Nazionale di Agrigento, nella sala “Epigrafi”. Nella Sicilia medievale, lo zolfo si esportò via mare, insieme ad altri prodotti, quali i tappeti rustici, le lane, gli schiavi, le schiave. Da Palermo a Maiorca, nel 1309, un nolo costava dieci tarì a “cantaro” per lo zolfo e cinque tarì cadauno per gli schiavi (1). Nel 1408 il barone di Mussomeli, Giovanni Castellar, ottenne da re Martino una concessione per la ricerca di zolfo nella sua baronia (2). Nel 1426 il barone Salvatore Tagliavia aprì la prima miniera nel feudo di Sommatino, su cui intervenne il Viceré per controllare se il suddetto barone avesse ottenuto o meno la licenza regia (3). Nel feudo di Riesi, dal 1487 esisteva la “Sulfara”, menzionata in un atto del notaio Catalano di Piazza. (4). Pure a Monte Grande di Palma Montechiaro, nel 1555 funzionava altra miniera di zolfo, la cui attività perdurò a lungo (5). Nel 1571, infine, un certo Giacomo Scaduni di Agrigento ottenne una ulteriore licenza di scavare miniere di zolfo nel territorio agrigentino (6). Le zolfare più vicine a Ravanusa, ove lavorarono i nostri conterranei, furono quella del Conte Bosco nel nostro stesso territorio, Tallarita in territorio di Sommatino e Riesi, Bifara, appartenente a Campobello, Suor Marchesa e Muculufa nei pressi di Butera e, in tempi più recenti, Pasquasia, in quel di Enna. I solfatari guadagnavano meglio dei lavoratori di altri settori. Nel Settecento, la paga di un jurnataru tenuto ad espletare 14 ore di lavoro, con età dai 12 ai 18 anni era di tarì 1 (uno), e dai 19 ai 70 anni di tarì 2 (due). Il solfataro, per lo stesso numero di ore lavorative, se picconiere (pirriaturi), guadagnava almeno cinque grani in più. Lavorando, poi, a cottimo (a la tacca), in rapporto al materiale estratto, il predetto poteva percepire sino a 3 (tre) tarì. In un anno, tolte domeniche, festività, interruzioni varie per malattia, maltempo, infiltrazioni d’acqua, frane ecc.., i solfatari portavano a casa mediamente 10 (dieci) once. Un’oncia, nel 1875, corrispondeva a £ 12,75. Il salario annuale del ceto impiegatizio nella cittadina era molto più basso: da due a sei once. Una salma di frumento costava tarì 51, di orzo tarì 24. Una casa 10 once, un mulo di masseria e varda 7 once, un asino 3 once, una capra 8 tarì, una pecora 7 tarì e un cavallo, da 10 a 14 once. Quel maggior salario in miniera intendeva compensare le deteriori condizioni di lavoro, il rischio mortale di frane e grisou, la silicosi e altre invalidanti malattie polmonari che minavano la salute dei solfatari. Si badi, allora non esistevano istituti pensionistici, d’infortuni sul lavoro, né assistenza ospedaliera e farmaceutica. Non può qui sottacersi l’ignominioso lavoro minorile nelle miniere dei carusi, usualmente al di sotto dei 12 anni, età ammessa dalle leggi allora vigenti. Per una paga inferiore a un tarì, dai dieci ai quindici grana (7), la miseria e la fame di quei tempi piegava i genitori a vendere i propri figli a un picconatore (pirriaturi), condannandoli all’oscurità dei cunicoli, a due trecento metri sotto terra. Nel decorso secolo, negli anni Trenta, la paga dei carusi fu annuale, di cento lire (il cosiddetto succursu muortu), cui si aggiungeva vitto e vesti. Lo zolfo grezzo, estratto dai cunicoli assieme a materiali rocciosi, era trasportato a spalla, con cesti o sacchi di lono, dai “carusi”, messi in fila indiana. Il primo portava in testa una “lumera” ad olio (causa di tante sciagure, laddove c’erano tracce di grisou, sostituita appresso da lampade Auer di sicurezza.) per rischiarare il cammino ai compagni. Deposto nei “calcheroni”, veniva fuso e ridotto a pani, colando “nni li gàviti” (forme) per la commercializzazione. Competeva, poi, ai mulattieri trasferirlo, a dorso di muli, nei luoghi di vendita. A questi subentrarono appresso i carrettieri. Nel 1878, apertosi lo scalo ferroviario Campobello-Ravanusa, lo zolfo vi fu convogliato per il trasporto a Licata. Da cui era esportato via mare. Nel 1910 fu realizzata una teleferica di vagoncini (li maugina) per trasportare lo zolfo dalla miniera “Tallarita” al predetto scalo, lungo un percorso di 14 chilometri. E ricordo la dura vita dei carrettieri carichi di zolfo, nel periodo bellico, quando la teleferica non funzionava, a frotte sull’antica rotabile per Licata, ben nota per le pericolose pendenze e gli arditi dossi. Il commercio di zolfo, qui si praticava, sin dalla fondazione della “terra” di Ravanusa. Un atto del notaio Gabriele Imperiale, datato 12 agosto 1619, riguarda una compravendita di zolfo, a Caltanissetta. Tra i venditori, tali Lorenzo Betti e Antonio Di Ganci, figura pure mastro Minico Di Francesco (magister Dominicus Defranco), abitanti tutti a Caltanissetta. Costoro si obbligavano a vendere cinquanta “cantarea sulfari al magnifico Leonardo Buscello di Sortino”, intervenuto pure a Caltanissetta, a 23 tarì per ogni cantaro, per un totale di 38 once, franco porto nel comune di Sortino. Furono presenti come testi Vincenzo Fasciana e Pietro Muranda. In calce al medesimo atto, risulta l’annotazione del 6 settembre 1619, sullo zolfo che fu dai venditori consegnato e dal compratore regolarmente pagato, presenti i testi Pietro Muranda e Marzio Murelles (8). ___________________ (1) ASPA, Notaio Bartolomeo de Citella 1308-1309, FF. 146v-148r, in I. Peri, O.c., p. 123. (2) ASPA, Real Cancelleria, Vol. 44 c 380 r, in Mirisola, Una Sicilia minore, cit. p. 331. (3) Ib., Vol. 57 c 129 v, in Mirisola, O.c., pp. 332-333. (4) ASEN, Notaio Gregorio Catalano di Piazza, Vol. 4859 bis, c 8 r. (5) T. Fazello, De Rebus Siculis, Ed. 1568, Deca I, Lib. V, Cap. 3. (6) ASPA, Real Cancelleria, Vol. 433, c 282. Salomone Marino, in ASS Nuova Serie, Vol. XXXII, p.533/34. (7) I quindici grana di paga (un tarì ne conta venti) divennero proverbiali. “Lu malannu, e li quìnnici grana” era un modo di dire, quando ad un danno subìto se ne aggiungeva un altro. (8) ASCL, Notaio G. Imperiale di Caltanissetta, Vol. 964, c 182 r v. LA ZONA INDUSTRIALE DI RAVANUSA La Zona Industriale, gestita dal Consorzio ASI (Area dello Sviluppo Industriale), è collocata in contrada Bifara - Mangiaricotta, a meno di 10 km dal centro abitato di Ravanusa, sulla strada statale “Torrente Braemi-Licata”, ben collegata a tutta la rete viaria isolana e nazionale. Pare sia rimasto a collaudare uno degli svincoli, già tutti predisposti ed ultimati, con una certa remora dello sviluppo commerciale. L’ASI avviò i lavori negli anni Settanta, predisponendo la scelta dell’area, l’acquisto dei terreni da diverse partite di proprietari e la stesura del relativo piano regolatore. Suddivise quindi l’area acquisita in 42 lotti, di cui 16 riservati alle attività industriali e 7 a quelle artigianali, man mano ceduti alle ditte interessate alla costruzione degli stabilimenti. Ha costruito, inoltre, un grande immobile polivalente ad uso uffici, il cosiddetto “Palazzo di Vetro” con pareti esterne a grandi vetrate. E continua, altresì, a gestire, le infrastrutture (strade interne, energia elettrica acqua, gas), addebitandone i costi alle imprese proprietarie degli immobili. Si è lamentata, tuttavia, nel passato una carenza nel settore di custodia e vigilanza che ha arrecato danni al predetto palazzo di vetro e consentito l’attecchimento di erbe infestanti e i ripetuti piccoli incendi. Nel 2005 sono in fase di produttività i seguenti padiglioni industriali: · BYDOC PRODUCTION S.R.L. Manifattura Maglierie e Confezioni. Proprietari i dottori Salvatore Scibetta, Amedeo Mosa, Mario Vella e Mario Falletta. Il lancio di una grandiosa campagna pubblicitaria, la vendita diretta al pubblico a prezzi di fabbrica di maglie, pantaloni, camicie e sciarpe presso il proprio lotto A5 della predetta Zona Industriale e l’incipiente avvio dell’esportazione fanno bene sperare in un prossimo incremento della produttività e dei posti di lavoro, malgrado la crisi nazionale nel settore dell’abbigliamento. · L’ANTICO COTTO dei Fratelli Lo Porto. Laboratori con quattro forni per la produzione di terracotte. · COMIS (Lavorazione e vendita di formaggi e affini). Proprietari i Fratelli Montana di Ravanusa . · FRATELLI LA GRECA. Produzione artigianale infissi in alluminio anodizzato. · GPS. Lavorazione gessi. Proprietari i Fratelli Gattuso. Nel 2004 hanno avviato l’attività programmata le seguenti ditte: · GMM. Tale Gruppo Manifatture Maglierie, già proprietario della BYDOC sta costruendo altri ampi padiglioni, accanto al proprio lotto A 5. · FERRO per carpenteria. Proprietario Calogero Alaimo. Padiglione in costruzione nel lotto attiguo a Bydoc e GMM. · EC.MER. Il padiglione è attrezzato per la rigenerazione e il riciclaggio degli oli usati di auto, attività provvidenziale contro il relativo inquinamento praticato da qualche sprovveduta officina isolana. · STUDIO COMMERCIALE. Padiglione costruito accanto al “Bydoc”. Attività programmata: formazione di commercialisti e commercianti, in fase di avviamento. Le altre ditte che seguono, invece, hanno predisposto purtroppo la cessazione di precedenti attività: · LARA FILTRI. Sorse, nel periodo aureo dell’on. Salvatore Lauricella, e fu l’antesignana azienda industriale che avrebbe potuto dare tanti posti di lavoro. La produzione di filtri per automobili fu avviata, ma non riuscì a trovare sbocco commerciale. Dovette, quindi, chiudere presto i battenti, lasciando a tutt’oggi liberi locali di un certo prestigio. Utili ad altra nuova attività industriale. · FABBRICA DI BIRRA. Proprietaria del padiglione e dei silos per la conservazione della birra, una ditta tedesca. Un’alta e simbolica colonna di barili e boccali di birra una grandiosa insegna si stagliano davanti ai cancelli del fabbricato “IL FUTURO E’ INIZIATO OGGI”, stridendo con l’amara realtà: la fabbrica ha dovuto chiudere i battenti. Prima di aprirli. · VERDURE VAL D’IMERA in confezioni. Chiusura attività e indizione dell’asta per vendita fallimentare dei locali. Proprietario Argento Agostino Davide. S. MARIA DEI RIMEDI E GLI ALTRI EDIFICI NORMANNI DI SICILIA Ringrazio il caro amico Carmelo D’Angelo, Ass. Prov. di Agrigento, per la segnalazione della chiesa mormanna S. Maria Maria dei Rimedi e per il dono con affettuosa dedica del volume di “V. NUCCIO, Il Convento-Caserma e la Chiesa di P.za Indipendenza” (Palermo 2005), che mi ha consentito di aggiungere un’altra perla al manto della Beddra Matri di Rivinusa. 1. - La chiesa “S. Maria de’ Rimedi” della Piazza Indipendenza di Palermo, è legata particolarmente al conte Ruggero per la guarigione miracolosa del suo esercito, dal morso di tarantole velenose, ottenuta dalla Vergine SS. Nel 1064 i Normanni avevano assediato la città per scacciarvi gli Arabi che dominavano in Sicilia da oltre due secoli. Durante una sosta presso il monte Tarantino furono assaliti da tarantole. Nel secondo attacco del 1071 accampati vicino alla città, accesero dei grandi falò per tenere lontani i ragni velenosi. Il Conte Ruggero pregò la Vergine di cui era devoto di liberare l’esercito costretto all’immobilità da quel morbo epidemico e con sorpresa s’avvide che con i falò “anche i tumori avvelenati si risolvettero in sudore e l’esercitò restò liberato da quella calamità”. Per ringraziare la Madonna fece edificare sul luogo una chiesa dedicata a “Santa Maria dei Rimedi” appunto per il rimedio ricevuto (ISIDORUS a S.J-PETRUS a S. Andrea, Historia Gen. Fatrum Disclceatorum ..Ord. B.V.M. Monte Carmelo, 2 vol. Romae 1668-71). Il Mongitore in “Storia sagra di tutte le chiese, conventi e monasteri” riferisce in splendido latino pure sui medesimi fatti raccontati dal Padre Pietro e sulle iscrizioni delle lapidi dei notabili ivi sepolti, compreso il Torremuzza. Gaspare Palermo nella sua “Guida istruttiva per Palermo e dintorni” del 1858, riporta la storia di cui sopra, e l’iscrizione riferita dal Cannizzaro, e da altri scrittori che si leggeva sopra la porta di detta chiesa: “Roberto Panormi Duce, et Siciliae Rogerio Comite imperantibus Panormitani cives, ob victoriam habitam hanc aedem B. M. sub Victoriae nomine sacrarunt A.D. 1071”. Dopo cinque secoli il barone Gravina di Catania sullo stesso sito fondò il Convento e vi ricostruì la predetta Chiesa della Vittoria nel 1630, nella cui Cappella dedicata alla Madonna delle Vittorie, sull’architrave lasciò l’immagine antica di M.Vergine a forma greca. Una descrizione dettagliata la troviamo nel manoscritto di Lazzaro Di Giovanni, Le opere d’arte nelle chiese di PA, della Bibl. Com. cittadina, pubblicato anche, a cura della prof. S. La Barbera, a Palermo nel 2000. Nella Cappella del Crocifisso, nel quinto spazio della volta, sopra l’arco vi era dipinta a fresco la vittoria dei Normanni sui Musulmani del Novelli. Sull’altare del Cappellone vi era pure un quadro in tela della Madonna della Vittoria in mezzo a un cerchio. La Chiesa e il Monastero nel 1860 furono confiscati e adibiti a magazzini e stalle per uso militare. Il card. Ruffini nel 1948, tramite il ministro Andreotti e il Pres. Reg. Alessi riuscì a riscattare la Chiesa dal Ministero della Guerra. Era spoglia al completo. Quadri, statue e arredi erano stati trasferiti in altre chiese e abbazie, o trafugati. Il cardinale donò per primo una statua marmorea gaginiana della Madonna dell’arcivescovato, ribattezzandola “S. Maria dei Rimedi” e con suo decreto 16 maggio 1953 la istituì come “Santuario Mariano Diocesano”, che affidò ai Padri Carmelitani Scalzi. Altri benefattori fecero il resto. Il Cardinale, rinunciatario del sarcofago in Cattedrale, ora vi riposa in eterno, per disposizione testamentaria, nella tomba a sinistra dell’altare dedicato alla Madonna, con epigrafe dettata dal medesimo: “ERNESTO CARD, RUFFINI ARCIVESCOVO DI PALERMO / E AMMINISTRATORE APOSTOLICO DI PIANA DEGLI ALBANESI / N.19.1.1888 – M. 11.6.1967 / «TANTO AMO’ LA MADONNA IN VITA / CHE HA VOLUTO ESSERE SEPOLTO ACCANTO A LEI»”. 2. - Gran parte della loro storia, peraltro la più bella e ricca di secoli, i Re normanni l’hanno scritta nei castelli e nelle cattedrali di Sicilia, soprattutto per quel caratteristico sincretismo di stili nord-europeo, bizantino e saraceno, che palesa la nota tolleranza e pacifica convivenza con popoli di razza e religione diversa. Oltre la menzionata S.Maria dei Rimedi, Palermo vanta dei Normanni il Palazzo Reale, la Cappella Palatina, la Zisa e la Magione, S.Maria dell’Ammiraglio, S.Cataldo, S.G. degli Eremiti. La Cattedrale, da primitiva chiesa bizantina, passò a moschea, e con la cacciata dei Saraceni, dal Guiscardo e dal Conte Ruggero fu restituita al vescovo Nicodemo, per come figura nell’affresco del catino dell’abside. Fu ricostruita nell’attuale grandiosità dall’arciv. Offamilio, di sangue reale normanno, nel 1184, che vi lasciò sul portale laterale i versetti coranici in arabo, d’invocazione a Dio. A Cefalù il Duomo è celebre per il Cristo Pantocrator. A Monreale, il Duomo, prima di essere cattedrale, fu basilica costruita per sé e per i famigliari dal basileus normanno Guglielmo II, che sul portale d’ingresso ai piedi della Madonna Odigitria, lasciò l’ardita iscrizione: “Pro cunctis ora, sed plus pro rege labora”. Di Petralia Soprana, l’antica “Petra” sicana e greca, citata in più fonti del III sec. a.C. come fortezza inespugnabile, i Normanni accrebbero il ruolo strategico con un turrito castello, e all’originario nome della città aggiunsero quello del profeta Elia, Patrono del Carmelitani Scalzi, che nel 1050 vi fondarono un convento, oggi chiesa S. Maria di Loreto. Non meno celebre il castello dagli stessi eretto su una rupe a strapiombo nel 1090, a Caccamo, del pari alla Chiesa Madre, anche per l’annuale rappresentazione in costumi d’epoca a metà agosto, che rievoca “La Castellana di Caccamo”. Troina (EN) fu la prima e più ampia diocesi di Sicilia fatta istituire (1082-1096) dal Conte Ruggero, che vi edificò il primo monastero basiliano e la torre normanna di allora ancor oggi funge da campanile della Chiesa Madre. Diverse chiese e vari castelli nel circondario si devono ai Normanni: ad Aidone, a Calascibetta, a Nicosia, a Sperlinga e a Piazza Armerina, ove annualmente il 14 a 15 agosto si ha la sfilata del Palio dei Normanni in costumi d’epoca per rievocare la sconfitta degli arabi e l’entrata del Conte Ruggero in città. Ivi tuttora si venera la Madonnina del Duomo, donata al Conte Ruggero da papa Nicolò II. L’emiro Camut di Agrigento, arresosi nell’assedio di Castrogiovanni al conte Ruggero ebbe salva la vita assieme ai suoi famigliari e battezzato finì esule volontario nella calabra Mileto con tutte le sue ricchezze. Nella città agrigentina con la conquista normanna l’antico tempio di Atena trasformato in chiesa fu abbandonato e Gerlando, designato vescovo da Ruggero, fece costruire nella parte alta della città l’odierna cattedrale. A Canicattì il Conte Ruggero ricostruì il castello arabo, ove trasferì le armi tolte ai Berberi nella battaglia di M. Saraceno, assieme alla sua spada e al suo scudo istoriati, ivi custodite sino a fine Ottocento. Della nostra S.Maria di Ravanusa, cui furono dedicate le due chiese, di Mistretta (ME) e di S. Giovani La Punta (CT) ne abbiamo scritto più volte a iosa. Rammentiamo solo, oltre al miracoloso antico simulacro, ora restaurato, il Palio della Madonna che nel Seicento e nel Settecento al suo di trombe e tamburi si correva ogni anno il 15 agosto, con la partecipazione della città di Licata. Messina con i Normanni che vi costruirono il palazzo reale, la Chiesa dei Catalani e l’impianto originario del Duomo divenne uno dei centri più importanti dell’isola. Ce lo ricorda l’annuale sfilata del 13 e 14 agosto dei Giganti Mata e Grifone difensori della città. Chiese e castelli normanni ebbero nel messinese Capizzi, Forza d’Agrò e Mistretta. A Mistretta la festa liturgica di S. Maria di Ravanusa è celebrata il 21 nov. (Presentaz. al Tempio di M.V.), mentre l’otto settembre ha luogo la processione della Madonna, con a guardia la Coppia dei Giganti Guerrieri. A Catania il conte Ruggero con i conci del teatro greco costruì la Cattedrale e nel 1076 il castello nella vicina Aci, donato poi al Vescovo da Ruggero II. Ad Adrano, i Normanni costruirono la torre-castello di via Umberto I, la Matrice e la Chiesa di S. Lucia, con annesso il grande monastero dovuto alla contessa Adelaide. Chiese e castelli normanni ebbero pure Caltagirone, Castiglione di Sicilia, Linguaglossa e Paternò. Il tempio dorico di Atena del V sec. a C. a Siracusa, su cui era stata costruita una basilica cristiana, elevata a cattedrale dal vescovo Zosino, in età normanna, ebbe sopraelevata la navata centrale e decorate con mosaici le absidi. Il porto, poi, della vicina Augusta, distrutto dai Saraceni nella suddetta età normanna fu riedificato e fortificato. Un cenno sulle normanne Marsala, Mazzara del Vallo, Erice, Castelvetrano, Caltanissetta e Scicli. A Marsala i Normanni costruirono il castello (oggi carcere), un convento, il Duomo e altre chiese. Mazzara fu scelta come capoluogo del Val di Mazzara. Erice, dopo la distruzione cartaginese, ribattezzata con gli Arabi Gebel-Hamel, rimase, però, deserta. Fu ripopolata dai Normanni che vi costruirono il castello sulle rovine del tempio di Venere e la chiamarono con Ruggero Monte S. Giuliano. Il fascismo nel 1934 le restituì il sicano nome di Erice (Eryx). A Scicli (RG), che fu città regia normanna, nel mese di giugno di ogni anno, si rievoca, con la Sagra di Milici, la battaglia dei Normanni vittoriosi sui Saraceni. Si venera, peraltro, nella Chiesa Madre il simulacro dell’omonima Madonna di Mìlici che scaccia due turchi col suo cavallo bianco. Tale iconografia, vera e propria macula dell’arte sacra che prese l’avvio dal cosiddetto “S. Giacomo Matamoro” (deturpa pure la volta della cattedrale agrigentina), si discosta dai canoni del cristianesimo. Sarà stata forse la vanagloria di quei guerrieri dalle mille vittorie, ma tradisce pur sempre la nota tolleranza degli stessi Normanni. Tale tolleranza, concludendo, resta ben registrata, nel sincretismo architettonico dei loro edifici sacri e profani. A motivo di ciò, ben poco in Sicilia è rimasto delle antiche chiese bizantine e moschee. L’elemento bizantino, nelle costruzioni normanne fu assorbito e fuso con quello romanico. Completò, poi, l’iniziativa il Seicento, arricchendola col barocco, quasi a celebrare la sicurezza e il fasto dell’uomo e del credente, dopo la crisi del protestantesimo calvinista.
|